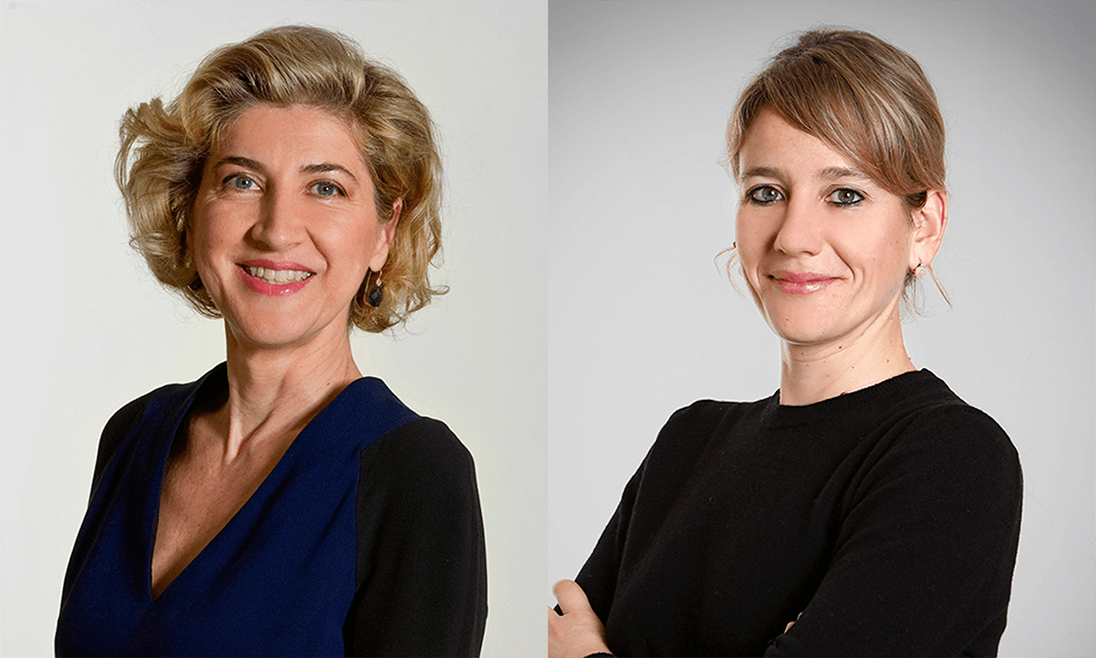Il presente contributo analizza le novità che il DL n. 209/2024, c.d. Decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), ha apportato all’istituto della finanza di progetto o project financing.
Con il DL n. 209 del 31 dicembre 2024 (“Decreto Correttivo”) il Governo è nuovamente intervenuto in materia di contratti pubblici, in forza della delega di cui all’articolo 1 comma 4 della Legge n. 78 del 21 giugno 2022[1], per razionalizzare e perfezionare l’impianto normativo del decreto legislativo n. 36 del 31 Marzo 2023 (cd “Codice dei Contratti Pubblici”).
In questo intervento il legislatore si è concentrato soprattutto sul partenariato pubblico-privato (“PPP”).
L’istituto del PPP, definito dal Codice dei Contratti Pubblici con l’ampia definizione di “un’operazione economica” è un importante strumento di collaborazione tra gli operatori economici privati e le pubbliche Amministrazioni[2]. Diffusosi nei primi anni ‘90, dapprima nel Regno Unito, poi in Italia ed in altri paesi europei, il PPP ha avuto il primo “battesimo” europeo nel 2004 con la pubblicazione del “Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni” della Commissione Europea. Il Libro verde, tuttavia, pur delineando le principali caratteristiche dell’istituto ed i principali tratti comuni emersi dalla prassi, non conteneva una definizione del PPP né una regolamentazione cogente dell’istituto[3].
Dieci anni dopo, la Direttiva 2014/23/UE, pur senza riferirsi espressamente al PPP[4], ha disciplinato in modo organico le concessioni, una delle tipologie di PPP contrattuale più utilizzata[5] in Italia. La Direttiva 2014/23/UE è stata recepita in Italia, inizialmente nel decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (“Codice 2016”) e, successivamente, nel Codice dei Contratti Pubblici.
Il Codice dei Contratti Pubblici, nella sua formulazione originaria, riconduceva le concessioni e le altre tipologie contrattuali di collaborazione tra pubblici e privati, quali la locazione finanziaria e il contratto di disponibilità, nel novero del PPP secondo un rapporto di specie a genere.
La finanza di progetto o “project financing” rappresenta certamente una delle forme più diffuse e finanziariamente efficienti di PPP. Il project financing consiste in un’operazione di finanziamento di un progetto infrastrutturale in cui il finanziatore fa affidamento, ai fini del rimborso del debito, esclusivamente sul flusso di cassa (cash flow) che lo stesso progetto genererà uno volta realizzato[6].
Si tratta della forma di finanziamento più rischiosa ma anche più sofisticata da parte dei finanziatori che prima di assumere il rischio del prestito, sottopongono la fattibilità del progetto a controlli accuratissimi da parte di consulenti specializzati.
La riforma introdotta dal Decreto Correttivo, mira a realizzare un coordinamento normativo chiaro, tra la finanza di progetto e il PPP. Con tale fine, all’articolo 174, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, la riforma specifica che la finanza di progetto è una forma particolare di concessione e quindi è anch’essa ascrivibile al genus del PPP.
L’istituto della finanza di progetto, può , dunque, ora essere utilizzato, senza alcun dubbio nelle concessioni di lavori o servizi.
L’affidamento delle concessioni in project financing può avvenire sia per iniziativa del pubblico che per iniziativa del privato, purché nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, e con procedure volte ad assicurare la concorrenza.
Il Decreto Correttivo si è concentrato proprio sulla regolamentazione del procedimento di affidamento, di cui all’art. 193[7] del Codice dei Contratti Pubblici, con l’intento di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato[8].
Il nuovo comma 1 dell’art. 193 chiarisce in primis che il project financing può essere utilizzato non soltanto per gli interventi inclusi negli strumenti di programmazione triennale del PPP[9], ma anche per proposte di privati in veste di promotori (il “Promotore”) non già incluse nella programmazione triennale.
Un’altra importante novità introdotta dal Decreto Correttivo, inserita al comma 2 dell’art. 193, codificando una fattispecie già diffusa nella prassi e suggerita dall’ANAC, è la previsione di una fase preliminare di “manifestazione di interesse”, obbligatoria per le amministrazioni pubbliche e facoltativa per il Promotore. Il Promotore può, infatti, tramite la presentazione della “manifestazione di interesse”, richiedere le informazioni ed i dati necessari per la formulazione della stessa. Qualora l’ente concedente ritenga sussistere un interesse pubblico alla proposta, trasmette all’operatore le informazioni richieste e ne dà notizia sul proprio sito istituzionale (e questo a beneficio di altri eventuali operatori interessati a loro volta a proporre proposte (cd “Proponente/i”))[10].
Nei commi 3, 4 e 5 dell’art. 193 è poi prevista la cd. struttura bifasica della proposta. La prima fase prevede la presentazione della proposta del Promotore che, all’esito di una valutazione comparativa con eventuali ulteriori proposte presentate da soggetti terzi (i.e. i Proponenti), si conclude con l’individuazione del progetto da mettere a base di gara quale progetto di pubblico interesse.
La seconda fase prevede la messa a gara del progetto individuato all’esito della valutazione comparativa della fase 1 e approvato dall’ente concedente.
La nuova formulazione della norma de facto anticipa il momento comparativo rispetto a quello dell’espletamento della procedura di gara. Se da un lato tale novità sembra avere il pregio di ridurre l’asimmetria informativa tra l’ente concedente e gli operatori economici, dall’altro potrebbe disincentivare potenziali promotori dall’investire risorse nell’elaborazione di un progetto che non venendo selezionato, precluderebbe loro il recupero dei costi sostenuti.
Ulteriore elemento di novità circa la proposta del Promotore è la previsione di un progetto di fattibilità più snello, al fine di ridurre le tempistiche e i costi di predisposizione. E’ evidente l’intento del legislatore di mitigare i rischi a cui sono esposti i Promotori, riducendo i costi e gli sforzi nell’elaborare le proposte. Ma quale sarà il costo pubblico di proposte meno elaborate?
La riforma, infatti, se da un lato ha il pregio di ridurre significativamente i tempi ed i costi di predisposizione del progetto di fattibilità, dall’altro, prevedendo un progetto di fattibilità più snello e posticipando, dunque, valutazioni più accurate in una fase successiva potrebbe portare ad un’incertezza sui costi reali dell’opera ed a ritardi per assenza di accuratezza.
Riguardo la fase della valutazione delle proposte, è previsto all’art. 193, comma 6 che l’ente concedente, individuate una o più proposte di interesse pubblico, le sottoponga a valutazione di fattibilità, con facoltà di convocare una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990. All’esito della procedura comparativa, verrà posto a base di gara il progetto di fattibilità selezionato, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Potrà trattarsi a seconda dei casi, del progetto di fattibilità originariamente presentato dal Promotore oppure di quello di un altro Proponente. Questa fase comparativa, non presente nella precedente formulazione, se da un lato favorisce indubbiamente la concorrenza, dall’altro comporta un indubbio allungamento dei tempi e può favorire l’instaurazione di contenziosi, e dunque ulteriori ritardi.
Il Decreto Correttivo contiene, infine, una riforma del diritto di prelazione che si applica al Promotore o al Proponente il cui progetto di fattibilità sia stato selezionato e posto a base di gara. In tal modo il Promotore o il Proponente, che non dovesse risultare aggiudicatario, potrà esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario alle medesime condizioni offerte dal miglior offerente. Il miglior offerente avrà, tuttavia, diritto al pagamento da parte del Promotore o del Proponente, dell’importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell’offerta, nel limite del 2,5% del valore dell’investimento, come risultante dal progetto di fattibilità posto a base di gara.
Se il Promotore o il Proponente, non esercita la prelazione, avrà esso diritto al pagamento, da parte del miglior offerente, delle spese per la predisposizione della proposta, sempre nei limiti di cui sopra.
Con l’estensione della prelazione anche ai Proponenti, il Governo sembra aver cercato di favorire la concorrenza e così fugare i dubbi sollevati recentemente dal Consiglio di Stato[11], anche ponendo una questione pregiudiziale alla CGUE[12] sulla compatibilità del diritto di prelazione con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, interpretati alla luce dei principi di proporzionalità, buona amministrazione ed efficienza della pubblica amministrazione. Tuttavia, è innegabile che la concorrenza esplichi al massimo i suoi benefici in presenza di un mercato avanzato. Ed in Italia il settore delle infrastrutture ancora non lo è.
Infatti, se si opera un confronto tra il mercato degli appalti e quello PPP, si rileva come nel 2023 il valore complessivo degli appalti di importo pari o superiore a Euro 40.000, sia stato in Italia pari ad Euro 283,4 miliardi[13] mentre il valore dei PPP è stato pari ad Euro 0,018969 miliardi[14].
Siamo sicuri che la strada scelta sia quella più giusta e che la concorrenza non fosse comunque adeguatamente tutelata dalla precedente formulazione?
A sostegno della precedente formulazione dell’istituto vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto Correttivo, oltre alla suddetta riflessione economica, si potrebbero ravvisare anche motivazioni più prettamente giuridiche: l’esercizio del diritto di prelazione che prima era riservato al solo Promotore (e che oggi, invece, risulta esteso al Proponente il cui progetto sia stato approvato e posto a base di gara) poteva essere letto come un riconoscimento dei diritti dell’ingegno che sarebbero spettati al Promotore per aver presentato per primo l’idea progettuale.
Resta, in ogni caso, sullo sfondo un serio tema di continuità e, dunque, di coerenza delle politiche legislative. Se è vero che da tempo si registra una “dialettica” tra l’istituto nazionale della prelazione e l’ordinamento europeo in materia di evidenza pubblica, è del pari vero che, solo poco più di un anno fa, in sede di redazione del vigente codice dei contratti pubblici, la prelazione aveva trovato piena conferma, nell’assetto poi rivisto in sede di Decreto Correttivo. Quell’originario assetto, peraltro, era stato definito con l’autorevolissimo avallo di specifici passaggi della Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici, ove la scelta di confermare in seno alla legislazione in materia di partenariati pubblico-privati il diritto di prelazione (in luogo o anche solo al fianco di altri sistemi premiali pur possibili) era stata preferita proprio per non incorrere nel rischio – che la prelazione si era ritenuto di per sé non provocasse – di “generare effetti distorsivi sul mercato inibendo la partecipazione di molti operatori economici alle forme di partenariato pubblico privato”.
In conclusione, le modifiche introdotte dal Decreto Correttivo inaugurano una nuova era per la finanza di progetto soprattutto ad iniziativa privata, caratterizzata da un’innovazione significativa della procedura di affidamento e dall’estensione anche al Proponente dell’istituto della prelazione.
L’intento del legislatore di aderire maggiormente ai principi concorrenziali europei è apprezzabile, ma le sfide permangono. La nuova procedura potrebbe risultare non solo più lunga e complessa, ma anticipando il rischio di contenzioso già nella fase preliminare di valutazione comparativa delle proposte concorrenti, meno efficace.
La valutazione del legislatore sembra aver bilanciato adeguatamente i rischi con la previsione di un progetto di fattibilità più snello ma solo l’applicazione pratica nelle prossime procedure di gare sarà in grado di confermare o smentire tale convinzione.
[1] Il Governo è intervenuto, in primis, con l’adozione del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) in attuazione dell’articolo 1 della Legge n. 78 del 21 giugno 2022 (recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e successivamente con l’adozione del decreto correttivo del 31 dicembre 2024. L’ articolo 1 comma 4 della Legge n. 78 del 21 giugno 2022 dispone che “[…] Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 [il riferimento è al D.lsg n. 36/2023, il Codice dei Contratti Pubblici], il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi”.
[2] P. Monea, “Un nuovo assetto per il partenariato pubblico privato” in “La nuova disciplina degli appalti pubblici”, Pacini Giuridica Editore (2023)
[3] I. Baisi “Il cammino normativo del partenariato pubblico privato nell’ordinamento eurounitario”
[4] A. Giovannini “Il partenariato pubblico-privato nel nuovo codice dei contratti pubblici” (2023). In particolare si veda: “Con una vera e propria fuga in avanti, il legislatore nazionale positivizza la figura del PPP, sconosciuta invece al diritto positivo europeo[4], ove pure questo rintraccia le proprie origini. Non pare, difatti, superfluo ricordare che la direttiva 2014/23/UE (così come la direttiva 2014/24/UE), di cui anche questo codice ovviamente costituisce attuazione, è dedicata alle concessioni e non fa alcun cenno al PPP”.
[5] Relazione sull’attività svolta dal Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (come di seguito definito) nell’anno 2023 in materia di Partenariato Pubblico Privato e Finanza di Progetto.
[6] Sebbene in dottrina non esista una definizione univoca di project financing, è possibile affermare che: “il Project Financing consiste in un’operazione di finanziamento di una particolare unità economica, nella quale un finanziatore fa affidamento, sin dallo stadio iniziale, sul flusso di cassa (cash flow) e sugli utili dell’unità economica in oggetto, come la sorgente di fondi che consentirà il rimborso del prestito e le attività dell’unità economica come garanzia collaterale del prestito (K.P. NEVITT, Project financing, V ed., Londra, 1989, trad. P.DE SURY, Roma, 1988, p. 3).
[7] Articolo che disciplina la procedura di affidamento in concessione di lavori o servizi mediante project financing.
[8] Parere del 27 novembre 2024 rilasciato dall’Adunanza della Commissione speciale.
[9] Art. 175, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici
[10] La Commissione Ambiente del Senato, nel parere rilasciato in vista dell’approvazione, aveva suggerito che, al fine di tutelare maggiormente il Promotore, venissero pubblicati soltanto i contenuti essenziali della proposta e non la stessa nella sua interezza.
[11] Ordinanza del Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 2024, n. 9449 che sul punto ha sollevato una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
[12] Corte Di Giustizia dell’Unione Europea.
[13] Relazione ANAC sull’attività svolta nel 2023.
[14] Tali dati emergono dalla relazione sull’attività svolta nell’anno 2023 dal Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (“DIPE”) in materia di Partenariato Pubblico Privato e Finanza di Progetto. Occorre, comunque, precisare che i dati del DIPE concernono solo i contratti di PPP registrati presso il portale di monitoraggio della Ragioneria dello Stato, che nel 2023 erano pari a 206.