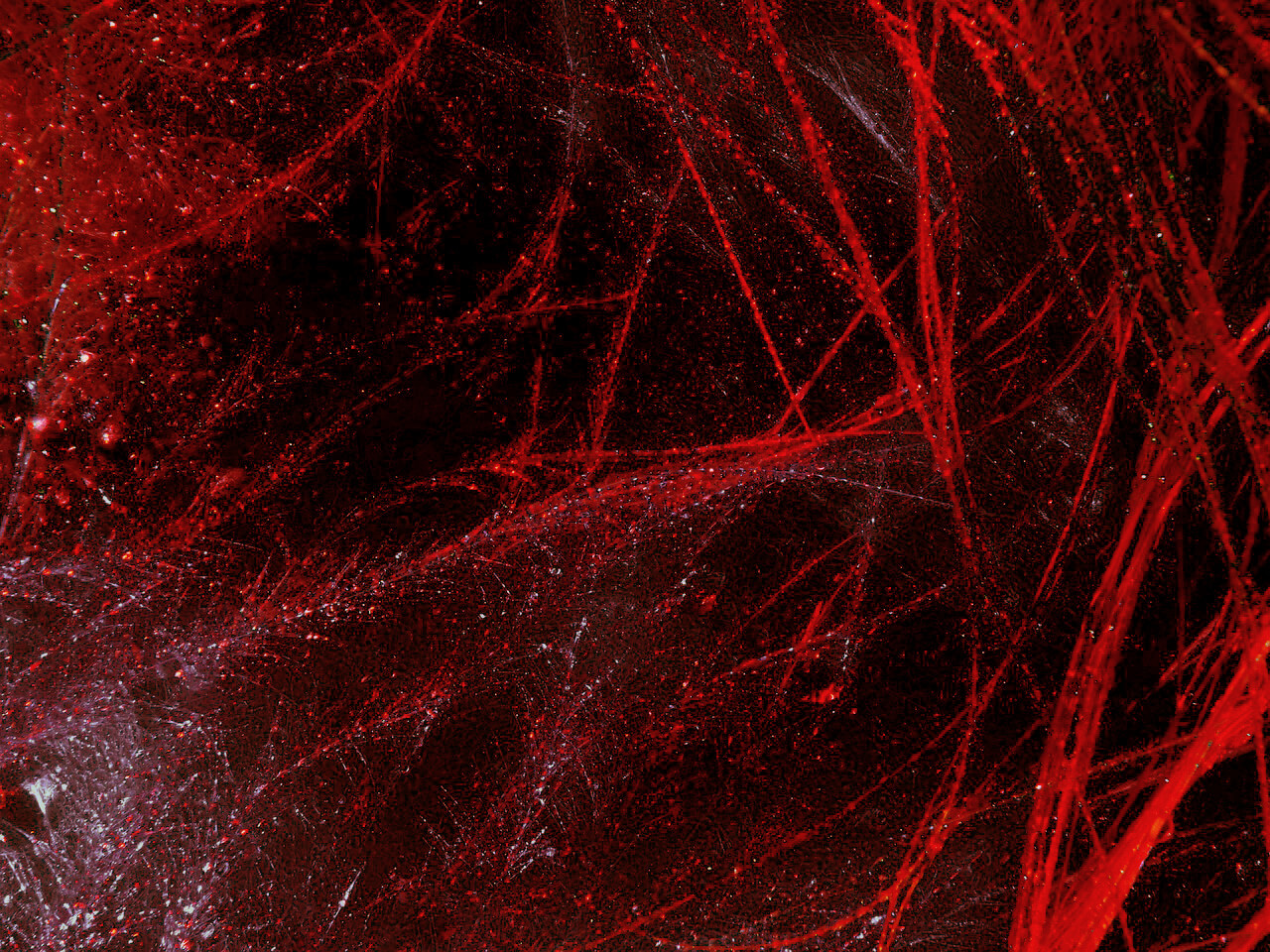Nel giudizio in cui il cliente contesti la reale sussistenza della giusta causa di recesso da un’apertura di credito invocata dalla banca, come costituita dalla sopravvenuta insufficienza della garanzia patrimoniale generica del cliente, conseguente al compimento di taluni atti dispositivi del patrimonio, va cassata la sentenza che, di fronte a una situazione di incertezza circa l’effettivo valore commerciale dei cespiti componenti il patrimonio residuo del debitore, si limiti a rigettare l’azione per mancato assolvimento – da parte del cliente – dell’onere di provare la sufficienza del patrimonio, a seguito degli atti dispositivi. Il giudice è infatti tenuto, in presenza di elementi indiziari forniti dall’attore (elencazione analitica delle proprietà residue, e relativa documentazione), e in mancanza di ulteriori allegazioni di allarme circa la solvibilità del debitore, a disporre una CTU estimativa, allo scopo di accertare l’effettiva fondatezza della contestazione.
La sentenza in epigrafe s’innesta nella tradizionale (e di significativa frequentazione in letteratura e giurisprudenza) tematica delle condizioni di legittimità del recesso della banca dal contratto di apertura di credito; precisamente, andando a convergere sul sub-tema costituito dal recesso «per giusta causa» (come contrapposto alla figura di recesso ad nutum). Di quest’aspetto, il provvedimento si viene a occupare in termini e con esiti che non solo sono, in ampia parte, condivisibili nel merito; ma che pure contribuiscono al progresso nell’elaborazione del tema, segnalandone una prospettiva nuova e ulteriore. Come una breve ricognizione della dinamica del giudizio – e in particolare della sequenza argomentativa svolta dalla Suprema Corte – è idonea a evidenziare.
Introdotto dal cliente (soccombente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in entrambi i gradi di merito), il ricorso verte, nei suoi termini essenziali, sulla contestazione relativa alle modalità procedimentali seguite dagli organi giudicanti ai fini della valutazione circa la ricorrenza in fatto del giustificato motivo addotto dal finanziatore a supporto del proprio recesso; motivo che, nel caso di specie, è quello della sopravvenuta insufficienza della garanzia patrimoniale generica (che sarebbe conseguita all’intervenuta alienazione di taluni cespiti da parte del debitore).
Più precisamente, la contestazione del ricorrente investe, da un lato, l’automatismo che i giudici del merito paiono aver instaurato tra il compimento di atti di disposizione, da parte del debitore, e la (sopravvenuta insufficienza del patrimonio e quindi) giustificatezza del recesso; come se «qualsiasi atto dispositivo del debitore … comport[i] una diminuzione delle garanzie tale da legittimare il recesso». Dall’altro, si censura il fatto che di fronte a una situazione di incertezza circa la sufficienza del patrimonio residuo («in mancanza di prova sull’idoneità del patrimonio del debitore … a soddisfare il credito della banca entro i limiti dell’affidamento») il giudice (del primo grado e così pure d’appello) abbia rifiutato di disporre una CTU, e abbia così ritenuta senz’altro sfornita di prova la difesa del cliente. A tale seconda censura va infine ad associarsi la distinta ma connessa contestazione per cui «il giudice del merito per non incorrere nel vizio di omessa pronuncia … de[ve] motivare in ordine al diniego della richiesta di CTU e/o in ordine agli elementi di fatto su cui (è) fondata la sua decisione».
L’iter decisionale dell’arresto si articola in tre momenti argomentativi. Due dei quali, in realtà, si limitano a confermare principi da tempo accolti dal formante giurisprudenziale.
Il passaggio logico-giuridico che avvia l’argomentazione è l’unico che si volge alla considerazione dei profili sostanziali di legittimità dell’atto di recesso. E viene a occuparsene allo specifico scopo di segnalare – mediante il richiamo a due noti precedenti: «Cass. Sez. 1, Sentenze nn. 9321 del 2000 e 4538 del 1997») – come la legittimità del medesimo venga a dipendere non solo dalla, comunque necessaria, «titolazione» dello stesso da parte della banca (l’indicazione del giustificato motivo addotto); e neppure dalla semplice valutazione dell’idoneità astratta del fatto invocato a integrare una giusta causa di recesso. Ché la valutazione della ricorrenza del giustificato motivo, e così pure la loro reale incidenza sul rapporto, richiedono di essere apprezzati in concreto.
Nel caso concreto, occorre dunque accertare non già il mero compimento di atti dispositivi da parte del debitore (e cioè il solo fatto della variazione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale generica), bensì la sussistenza di un reale peggioramento delle prospettive di rientro del creditore: «non basta un qualsiasi atto di disposizione del proprio patrimonio perché il creditore bancario possa dirsi, a giusto titolo, allarmato dal comportamento del suo debitore». D’altro canto, la natura lato sensu cautelare dell’istituto del recesso per giusta causa fa sì che non si richieda un peggioramento patrimoniale tale da identificarsi con una «insolvenza» nel senso fallimentaristico del termine (osserva il Collegio, sul punto, che «in tal modo si richiederebbe ad essa, irragionevolmente, di recuperare il proprio credito quando questo sia divenuto addirittura irrecuperabile»)[1].
Com’è poi naturale, l’affermazione di siffatti presupposti sostanziali ridonda nella dimensione processuale: nel senso che «il giudice non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell’ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, deve accertare che il recesso non sia esercitato con modalità impreviste ed arbitrarie». Il richiamo alla necessaria valutazione in merito alla conformità a buona fede delle modalità concrete di esercizio dell’atto negoziale, sembra peraltro assumere, nel presente contesto[2], non più di una funzione di conferma della natura concreta della valutazione sulla sussistenza della giusta causa, secondo una sorta di argomento a fortiori. Come a dire: dovendo il giudice valutare circostanze ulteriori rispetto al rispetto alla mera sussistenza della giusta causa (quali quelle che giustificano una exceptio doli), è sicuro che il vaglio su quest’ultima debba assumere connotati particolarmente penetranti.
Si esaurisce in un richiamo a uno dei precedenti storici della materia anche il secondo passaggio argomentativo, che affronta il punto della distribuzione dell’onere della prova circa i fatti a fondamento dell’asserita illegittimità del recesso. Onere che il giudicante, recisamente, addossa al cliente: «il debitore il quale agisca per far dichiarare arbitrario l’atto di recesso di una banca dal rapporto di affidamento di credito e, in particolare, per far affermare che il recesso non sia stato rispettoso della regola della giusta causa (in quanto prevista dal contratto stipulato dalle parti) ha l’onere di allegare che le giustificazioni date dalla banca non risultano ragionevoli, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale, così come residuata dopo gli atti dispositivi compiuti». In proposito, è interessante notare che l’affermata spettanza al cliente dell’onere della prova nemmeno risulta oggetto di contestazione nel ricorso; e tale dato sembra segnalare che si tratta di un aspetto assunto come ovvio e scontato (per un cenno critico sul tema v. infra, in fine delle presenti note).
L’importanza dell’arresto sarebbe però modesta se si arrestasse ai due passaggi appena riportati. Nei fatti, il reale portato della decisione si rinviene nel terzo e ultimo passaggio, che propriamente attiene alle dovute modalità di espletamento (e annessa motivazione) della funzione istruttoria da parte dell’organo giurisdizionale, nella valutazione della ricorrenza della giusta causa di recesso. E va così a toccare il tema, assai delicato, del rapporto tra principio dispositivo (nel suo corollario costituito dal principio onus incumbit ei qui dicit) e poteri di iniziativa istruttoria del giudice.
Sul punto, il dictum della Suprema Corte viene ad attribuire rilievo pregnante al secondo polo di tale dialettica, enucleando un vero e proprio dovere dell’organo giudicante di disporre una CTU (ovvero di motivare analiticamente in ordine alle ragioni di un eventuale rifiuto). Obbligo che, nella ricostruzione del giudicante, viene a giustificarsi in considerazione del quantum di prova già assolto dal cliente, «il quale, dopo aver allegato (con la analitica specificazione dei cespiti oggetto del patrimonio, suo e dei fideiussori), la consistenza di tali beni, posti a presidio degli obblighi assunti con la Banca, ha vanamente richiesto – nel caso che del loro valore si dubitasse – una CTU volta all’apprezzamento degli stessi».
Insomma, la condizione di dubbio indotta dalle allegazioni e dagli sforzi di prova del cliente circa la sufficienza del proprio patrimonio non può legittimamente essere ridotta al livello, semplificatorio e sminuente, di un onere non assolto. Al contrario, «nel dubbio sulla valutazione del patrimonio residuo …, ed in mancanza di ulteriori allegazioni di allarme circa la solvibilità dei debitori, il giudice di merito avrebbe dovuto quantomeno disporre una CTU estimativa, allo scopo di verificare sia pure indirettamente – l’affermazione dell’esistenza di indici apprezzabili relativi al comportamento arbitrario del creditore istituzionale». Ciò posto, si pone allora contra legem il comportamento del giudice del merito che «non solo … non ha disposto tale CTU ma ha affermato, senza alcuna effettiva motivazione, l’esistenza in atti della prova dell’insufficienza del patrimonio dei debitori, senza specificare le ragioni, con una evidente carenza motivazionale, tale da farla qualificare come vera e propria motivazione apparente».
La decisività che il profilo da ultimo riferito ha assunto ai fini del concreto esito del ricorso, insieme con la sua novità (almeno nella materia de quo), richiede, nella presente sede, qualche brevissimo spunto di valutazione. Il quale, a mio parere, deve muovere dall’affermazione della sicura condivisibilità della decisione concretamente adottata, e quindi pure del principio di diritto che l’ha sorretta.
Ciò che sembra degno di una particolare sottolineatura è, in particolare, il nesso che, nella vicenda in discorso, viene a instaurarsi tra regole di esercizio della funzione istruttoria da parte del giudice e configurazione tipica della fattispecie di recesso. Il tema delle corrette modalità del vaglio la ricorrenza della giusta causa, che pure si assesta su di un livello processuale in sé pure piuttosto tecnico, si nutre infatti di un’intima connessione con i relativi presupposti sostanziali. Nei fatti, si tratta di un punto che va a dispiegare sulla fattispecie del recesso «per giusta causa» effetti conformativi di momento rilevante.
L’interferenza tra i menzionati piani sta in ciò che la misura della profondità del vaglio del giudice nel controllo delle concrete condizioni di esercizio dell’atto (di cui la CTU si pone – nel caso di specie – come strumento conoscitivo essenziale), può venire, nei propri risvolti effettuali, a mutare le stesse caratteristiche essenziali della fattispecie di recesso. Nei fatti, la pretesa di standard probatori esasperatamente rigorosi (per ampiezza e profondità) in capo al cliente, in una con un approccio del giudice da «convitato di pietra» (rifiuto di disporre una CTU in presenza di un quadro probatorio incerto e complesso), porta in sé – in una serie non marginale di casi – il rischio di un surrettizio snaturamento della natura (causale) del recesso, attraendola nell’area delle figure di recesso ad nutum.
Stante un simile pericolo, la prospettiva di un obbligo del giudice di disporre – a fronte di situazioni di incertezza circa la prova o, volendo ricorrere a un’espressione tralatizia, di semiplena probatio – una CTU, e così pure il richiamo all’esigenza di una motivazione analitica delle ragioni fattuali della ritenuta legittimità del recesso (e quindi della inutilità di ulteriore attività istruttoria), appare quindi come un naturale pendant disciplinare della fattispecie sostanziale: una regola processuale, cioè, coerente e adeguata alla natura «causale» del recesso, e quindi alla tutela degli interessi protetti dalla stessa.
La correttezza di una simile prospettiva (di vaglio minuto della sussistenza dei presupposti materiali della legittimità del recesso) viene poi ad assumere una fondatezza e, per così dire, una profondità concettuale maggiori là dove si consideri il contesto ordinamentale in cui questa fattispecie di recesso si colloca. Che non è quello dell’exit da un contratto qualsiasi (e non ulteriormente qualificato), bensì quella di un atto che si pone nell’ambito di un’impresa esercitata professionalmente dal «creditore istituzionale» banca. Da una siffatta strumentalità viene allora necessariamente a conseguire che le condizioni e modalità procedimentali di controllo sulla legittimità dell’atto singolo – nella sua programmatica serialità – salgono a condizioni di controllo sull’attività: in via segnata, di verifica della rispondenza dell’agire della banca al criterio della sana e prudente gestione, come declinata, nel caso di specie, nella nozione di «meritevolezza creditizia» del cliente[3].
Ciò detto, il discorso richiede di essere completato con una breve notazione in merito al punto – che nella fattispecie contenziosa in discorso sembra essere restato sotto traccia – della distribuzione dell’onere della prova in merito alla legittimità del recesso. A tal riguardo, può dirsi che l’ordine di considerazioni appena svolto, circa i nessi tra disciplina del contratto e corretto agire negoziale dell’impresa, sembra rilevare anche rispetto ai termini di applicazione della regola dell’art. 2697 c.c., conferendo alla questione margini di sicurezza inferiori rispetto a quelli che esprime il già riferito orientamento della Corte Cassazione[4].
E infatti, se è vero che, d’acchito, la regola dell’incombenza dell’onere sul cliente sembra razionalmente collegabile al fatto che è quest’ultimo ad invocare l’illegittimità del recesso, di tal che il fatto della permanente sufficienza della garanzia generica appare atteggiarsi a elemento costitutivo della relativa eccezione, va pure considerato – in senso opposto – che è l’atto di recesso a rimuovere il termine di adempimento, che la persistenza del rapporto assicura al debitore. In altri termini, la sopravvenuta insufficienza patrimoniale del debitore potrebbe intendersi quale elemento dell’attuale esigibilità del credito. Tanto più che, nel caso di specie, si verte in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: per l’effetto, la posizione processuale del cliente essendo, ai fini della distribuzione dell’onere della prova, quella di convenuto.
Ora, restando il ragionamento a questo livello, l’atto di stabilire quale tra le due alternative ricostruttive considerate sia quella corretta assume contorni assai incerti: posto che entrambe le alternative appaiono come plausibili. Considerato invece il problema nella prospettiva della dimensione imprenditoriale in cui si colloca il recesso, la relativa soluzione appare molto più agevole da individuarsi: se l’atto di chiusura del rapporto di credito costituisce una decisione imprenditoriale del finanziatore, e il vaglio circa la sussistenza di una giusta causa di recesso mira ad assicurare la coerenza di tale decisione con la regola della sana e prudente gestione, è più che sensato che sia chi questa decisione ha assunto a dover illustrare al giudice come è giunto a una simile determinazione.
[1] Piuttosto, la giusta causa di recesso in esame andrà ragionevolmente a misurarsi sulla – diversa e minore – nozione di insolvenza accolta dall’art. 1186 c.c.
[2] E ciò perché l’«ipotesi tipica» di giusta causa di recesso consiste non già dal compimento dell’atto, bensì dalla sopravvenuta insufficienza patrimoniale. A tal riguardo, va però detto che i dati riportati nel testo del provvedimento non danno conto della concreta conformazione della clausola contrattuale. È peraltro evidente che, di fronte a una clausola la cui formulazione fosse centrata sul compimento dell’atto (sulla linea concettuale di una «garanzia negativa»), il tema della valutazione della coerenza a buona fede delle modalità concrete dell’esercizio dell’atto verrebbe ad assumere una significativa importanza; salva, com’è ovvio, ogni questione sulla validità del patto.
[3] Per un’ampia indagine sui nessi correnti tra sana e prudente gestione, merito di credito del cliente e regole dell’agire negoziale, v. Sartori,Deviazioni del bancario e dissociazione dei formanti: a proposito del diritto al credito, in Giust. Civ., 2015, I, 569 ss., spec. 606 ss.
[4] Si riporta qui la stringa già trascritta supra: «il debitore il quale agisca per far dichiarare arbitrario l’atto di recesso di una banca dal rapporto di affidamento di credito e, in particolare, per far affermare che il recesso non sia stato rispettoso della regola della giusta causa (in quanto prevista dal contratto stipulato dalle parti) ha l’onere di allegare che le giustificazioni date dalla banca non risultano ragionevoli, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale, così come residuata dopo gli atti dispositivi compiuti».