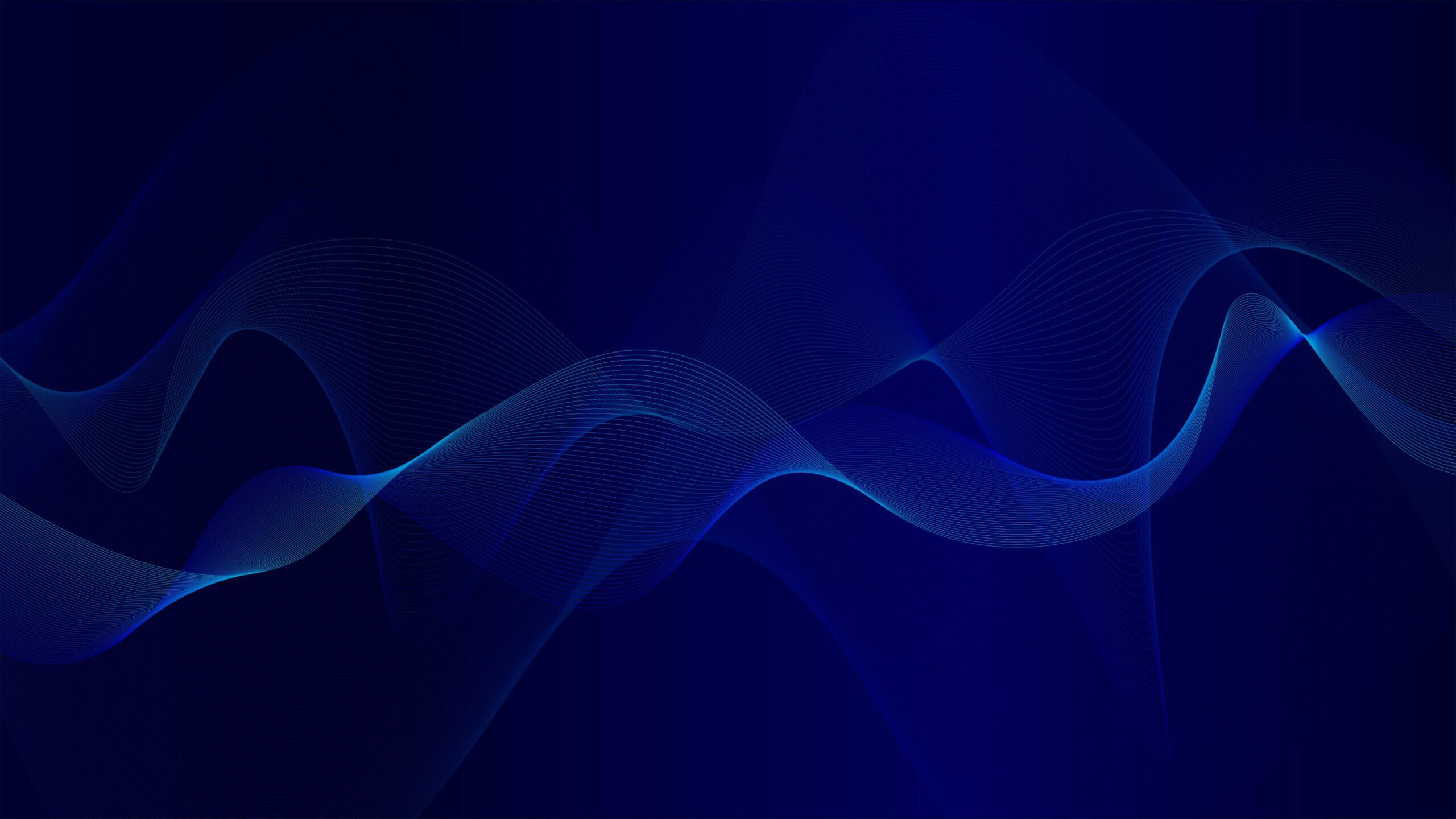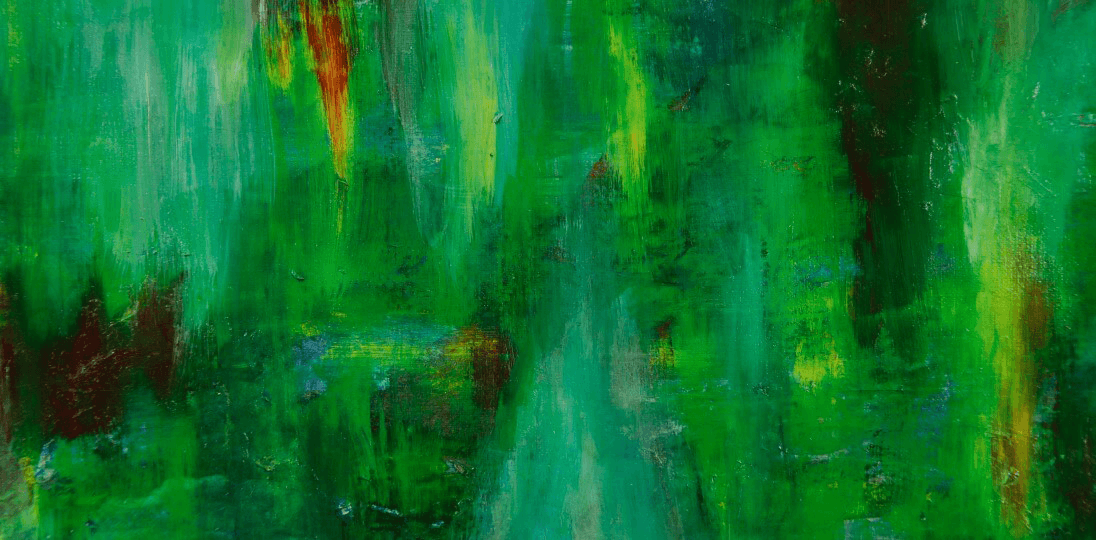Con la recentissima sentenza n. 44378/2022, la Cassazione Penale ritorna sulle tematiche relative alla natura qualificatoria dei crypto assets, questa volta con esiti che, ad avviso di chi scrive, danno adito a più di una perplessità sotto il profilo interpretativo. In linea generale, il dictum della Cassazione sembra non tenere in alcun conto le più recenti evoluzioni normative in materia che, quandanche non ancora cogenti, stanno contribuendo a delineare in maniera sempre più puntuale il quadro regolamentare relativo alla qualificazione dei crypto assets ed ai servizi prestati in relazione ai medesimi.
Ciò premesso, pur condividendo l’intento di fondo di garantire una maggior tutela del pubblico che si interfaccia con gli operatori in tale ambito, ed in linea con uno stare decisis che sta andando sempre più consolidandosi in materia di offerta al pubblico di crypto assets “reclamizzata” quale forma di investimento (si segnalano, in particolare, le precedenti sentenze delle Cassazione Penale, n. 26807/2020 e n. 44337/2021), meno convincente pare questa volta sia l’iter argomentativo sia l’impianto terminologico adottati per fondare la propria decisione.
In estrema sintesi, la presente pronuncia trae origine da una attività di initial coin offering (ICO) che avrebbe avuto quale finalità la creazione di una piattaforma decentralizzata di servizi logistici peer-to-peer (in dettaglio, inerenti ad alcuni servizi di spedizione). In particolare, i contributori avrebbero conferito Bitcoin nella loro disponibilità, a fronte dei quali la piattaforma avrebbe corrisposto un determinato numero di token destinati a permettere l’utilizzo dei servizi prestati dalla piattaforma stessa. Secondo la Corte, il titolare della piattaforma avrebbe realizzato una condotta di autoriciclaggio, di cui all’art. 648-ter, comma 1, c.p., essendo integrato il reato presupposto di cui all’art. 166, D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), in materia di abusivismo in attività finanziaria (i.e. mancato rispetto artt. 94 ssg., TUF) e da cui sarebbe dovuto derivare il sequestro preventivo di un portafoglio digitale (cd. wallet) contenente i Bitcoin raccolti nel contesto della citata offerta.
Alla luce delle sopra richiamate caratteristiche dell’ICO, i token oggetto di emissione parrebbero pertanto riconducibili al novero degli “utility token”, ossia quel tipo di cripto-assets destinato a fornire l’accesso a un bene o a un servizio fornito dall’emittente del token; questo perlomeno secondo l’impianto definitorio attualmente contenuto nel contesto del Regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività (“MiCAR”), il testo della cui proposta è stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio europeo in data 5 ottobre 2022 sebbene a tutt’oggi, a distanza di oltre due anni dalla relativa proposta, non sia ancora intervenuta la definitiva approvazione da parte del Parlamento europeo.
Ciò posto, si rileva che la Cassazione ravvisa la sussistenza degli elementi di finanziarietà dell’operazione – con conseguente applicazione delle tutele di cui al TUF applicabili in caso di offerta al pubblico di “prodotti finanziari” – e tra questi l’“aspettativa di ottenere un rendimento, costituito dalla corresponsione di altre monete virtuali che avrebbero permesso la partecipazione alla piattaforma, dal valore variabile a seconda del momento dell’acquisto e che avrebbe acquistato maggior valore se il progetto relativo alla piattaforma avesse avuto successo”. Questo è uno degli aspetti maggiormente critici presenti nella ricostruzione operata dalla Corte, in quanto non si assiste nell’intero corpo della sentenza né a una articolata disamina in ordine alla causa negoziale (asseritamente finanziaria) del contratto, secondo i principi già consolidati a livello giurisprudenziale[1], né a più puntuali richiami al contenuto del white paper redatto in vista dell’ICO al fine di corroborare la ricostruzione operata. Non da ultimo, nel medesimo solco, giova ricordare che, sulla scorta dell’insegnamento di Consob, il mero apprezzamento del bene (token) nel tempo non sembrerebbe integrare motivo legittimante la riconduzione dell’operazione inerente alle “valute virtuali” alle operazioni aventi connotati di investimento: la Corte di Cassazione sembra, nel presente caso, non tenere conto in alcun modo di tali rilievi[2].
Inoltre, più di un passaggio della sentenza denota una certa superficialità nell’utilizzo terminologico finalizzato alla qualificazione della fattispecie in esame. Ad esempio, accostamenti logici che qualificano la “moneta virtuale” come “mezzo di scambio o strumento finanziario” (equiparando la “finalità di investimento” prevista dalla normativa citata dalla Corte al concetto di “strumento finanziario”) non ci sembrano potersi collocare oggi in un impianto argomentativo di una Suprema Corte, nel contesto di un quadro regolamentare che va via via sviluppandosi in maniera sempre più dettagliata rispetto alla qualificazione dei crypto assets.
L’acritica assimilazione tra “finalità di investimento” e “strumenti finanziari” non tiene conto delle ampie discussioni che sia a livello di regolatori che a livello dottrinale sono intervenuti sin ad oggi per arrivare ad una qualificazione sempre più precisa della fattispecie in esame; ad esempio collocando alcune fattispecie nell’ambito dei “prodotti finanziari” in luogo della più circoscritta categoria degli “strumenti finanziari” anche in considerazione del principio, cristallizzato tanto nell’ordinamento dell’UE quanto in quello italiano, del numerus clausus degli “strumenti finanziari”. Non si possono non considerare le incertezze interpretative e le conseguenze giuridiche che derivano da un impianto argomentativo che sovrappone categorie giuridiche che ad oggi, invece, vanno assumendo connotati via via sempre più contornati.
Ancora, non convince il richiamo alla sentenza n. 195/2017 del Tribunale di Verona, che aveva de plano ricondotto i Bitcoin al novero degli “strumenti finanziari”, in quanto inconferente rispetto alle conclusioni a cui giunge le Cassazione, che si assesta sui principi di diritto delle precitate sentenze della Corte del 2020 e del 2021, secondo cui la vendita di Bitcoin, ove “reclamizzata” come proposta di investimento – sussistendone i presupposti – è assoggettata agli obblighi in materia di offerta al pubblico stabiliti dal TUF, essendo in tal caso sussumibili dette “valute virtuali” nella categoria dei “prodotti” (ma non anche in quella, più circoscritta, degli “strumenti”) finanziari.
Da ultimo, la riduzione del ruolo dell’“exchange” di crypto assets a quello di cambiavalute di “bitcoin et similia” parrebbe essere indice di una scarsa sensibilità delle corti nostrane rispetto a pratiche di mercato quantomai multiformi. Ancora, sarebbero forse stati più precisi, anche alla luce del tenore lettera della norma, riferimenti alle “valute virtuali” piuttosto che alle “monete virtuali” od ai “prestatori di servizi di portafoglio virtuale” piuttosto che ai “gestori di portafoglio virtuale”.
In conclusione, pur ribadendo che pare assolutamente condivisibile l’intento della giurisprudenza di tutelare nella maniera più ampia possibile il pubblico che interagisce con prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali, si è dell’avviso che le Corti, anche alla luce dell’attuale stato di sviluppo della normativa, dovrebbero cercare di adottare un impianto argomentativo che aiuti gli operatori del mercato a indirizzare la propria attività nella maniera corretta. Ciò, purtroppo, non può avvenire se non si adotta un impianto terminologico e definitorio il più possibile preciso rispetto alle fattispecie in esame, generando, piuttosto, incertezze per chi intende operare in questo momento di parziale vuoto normativo. Sul punto, non aiuta sicuramente il fatto che l’entrata in vigore ed applicabilità della normativa europea (MiCAR) stiano subendo ulteriori ritardi; sarebbe sicuramente auspicabile disporre quanto prima di un quadro normativo consolidato, che possa arginare l’attività supplettiva della giurisprudenza, che ha dovuto fino ad oggi sopperire ad una pressochè totale mancanza di indicazioni da parte del legislatore.
[1] Ci si riferisce a Cassazione Civile, Seconda Sezione, sent. n. 2736/2013, secondo cui “la causa negoziale è finanziaria [allorquando] la ragione giustificativa del contratto, e non il suo semplice motivo interno privo di rilevanza qualificante, consiste proprio nell’investimento del capitale (il “blocco” dei risparmi) con la prospettiva dell’accrescimento delle disponibilità investite, senza l’apporto di prestazioni da parte dell’investitore diverse da quella di dare una somma di denaro”.
[2] Ci si riferisce a quanto rilevato da Consob, Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività Documento per la discussione, 12 marzo 2019, par. 2.