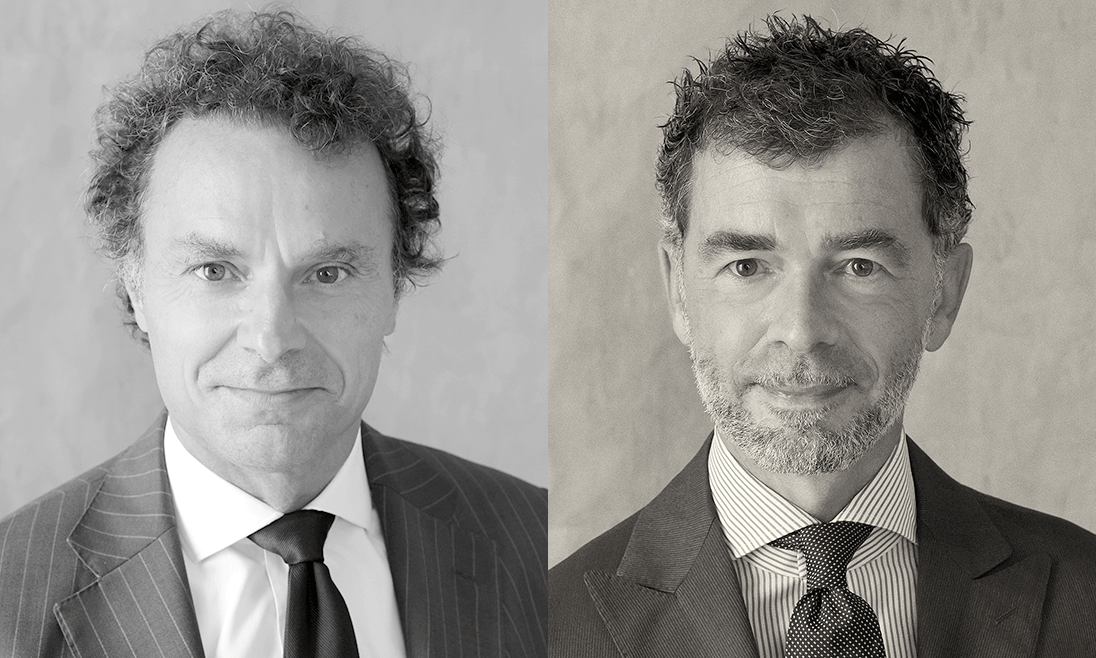1. Premessa – 2. Gli indizi per la valutazione dell’abuso secondo la Corte di Giustizia – 3. La discriminazione dei fondi di investimento esteri rispetto a quelli istituiti in Italia in tema di tassazione dei dividendi – 4. La possibilità di estendere il principio di non discriminazione ai fondi istituiti in Paesi terzi – 4.1 Clausola di “standstill” – 5. Conclusioni
1. Premessa
Con il presente lavoro si intende tornare su un tema – quello dei dividendi distribuiti a favore di holding estere controllate da fondi di investimento – già analizzato in un precedente contributo dedicato all’approfondimento della sentenza 26 febbraio 2019 resa dalla Corte di Giustizia Europea nelle Cause riunite C-116/16 e C-117/16 (le c.d. sentenze danesi). In questa sede, dopo avere brevemente ripercorso i principi sanciti nella citata sentenza, ci si intende soffermare a valutare se una generalizzata applicazione della nozione di beneficiario effettivo in funzione antielusiva, come quella suggerita dalla Corte, sebbene motivata dalla legittima volontà di contrastare pratiche fraudolente o abusive poste in essere essenzialmente al fine di conseguire un vantaggio fiscale in contrasto con la finalità e la ratio della normativa tributaria applicabile, non finisca in realtà – in certi casi – per condurre a risultati altrettanto poco appaganti in quanto in contrasto con le libertà fondamentali sancite dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito il “Trattato” o “TFUE”).
2. Gli indizi per la valutazione dell’abuso secondo la Corte di Giustizia
Come osservato in un nostro precedente intervento[1], la Corte nella sentenza sulle Cause riunite C-116/16 e C-117/16 pare aver esteso la portata antielusiva del requisito del beneficiario effettivo (che il legislatore europeo ha testualmente previsto solo nella Direttiva interessi e royalties) anche nella Direttiva madre-figlia. Ed infatti, nell’individuare gli indizi che – secondo la Corte – possono giustificare il disconoscimento dei benefici della Direttiva madre-figlia, la sentenza richiama tutta una serie di circostanze che sostanzialmente riprendono quelle analizzate dallo stesso Commentario all’art. 10 del Modello di Convenzione OCSE al fine di accertare l’eventuale presenza di strutture conduit. Più in dettaglio, tra gli elementi che secondo i giudici comunitari devono essere presi in considerazione per valutare la presenza di un comportamento abusivo volto a beneficiare indebitamente dell’esenzione da ritenuta disposta dalla Direttiva madre-figlia si ricordano, in particolare:
- “il fatto che i dividendi vengano ritrasferiti, integralmente o quasi ed entro un lasso di tempo molto breve successivo al loro percepimento, dalla società percettrice a entità non rispondenti ai requisiti d’applicazione della Direttiva 90/435”[2];
- la circostanza che, proprio per il fatto di dover ritrasferire i dividendi a favore di una terza società, la società intermedia realizzi “solo un utile imponibile insignificante”[3];
- “l’assenza di una effettiva attività economica”. Tale circostanza deve essere valutata tenendo conto “delle peculiarità che caratterizzano l’attività economica in questione” e può essere dedotta “da un’analisi complessiva dei pertinenti elementi attinenti, in particolare, alla gestione della società, al suo bilancio d’esercizio, alla struttura dei suoi costi ed ai costi realmente sostenuti, al personale impiegato nonché ai locali ad alle attrezzature di cui dispone”[4];
- le modalità di finanziamento dell’operazione tramite contratti infragruppo e l’eventuale sottocapitalizzazione della società madre[5];
- “l’assenza, nelle società interposte, del potere di disporre economicamente dei dividendi percepiti”. La Corte precisa ulteriormente che rilevano a tal fine “non solo obblighi contrattuali o legali” che impongono alla società madre percettrice dei dividendi di ritrasferirli a terzi, ma anche il mero fatto che “fondamentalmente” i suddetti dividendi vengano ritrasferiti[6].
Come risulta evidente dal predetto elenco, nel descrivere gli elementi da tenere in considerazione per verificare la genuinità delle strutture che possono legittimamente beneficiare della Direttiva madre-figlia, la Corte si sofferma (forse eccessivamente) sugli aspetti quantitativi e temporali legati alla distribuzione dei dividendi lungo la catena partecipativa, tralasciando di valutare altri aspetti attinenti alla funzione economica ed organizzativa svolta dalla holding in seno alla struttura che invece possono risultare essenziali per comprendere il ruolo svolto dalla holding e valutarne l’eventuale artificiosità[7]. Questa posizione è mitigata solo in parte dalla timida ammissione che il giudizio sull’esistenza di una effettiva attività economica deve essere adattato in ragione delle specifiche peculiarità dell’attività svolta[8].
Con specifico riferimento alle strutture societarie costituite dai fondi di private equity, è noto come solitamente questi investitori istituzionali pongano in essere i propri investimenti attraverso la costituzione di una o più società veicolo localizzate in Paesi dell’Unione Europea che a loro volta costituiscono una o più società italiane destinate dapprima ad acquisire la società target per poi essere incorporate in essa. Le strutture di investimento costituite da tali fondi rispondono a specifiche esigenze economiche che attengono a ragioni extra-fiscali e che derivano dalla complessità delle operazioni condotte. A mero titolo esemplificativo si osservi che la catena di holding e sub-holding serve:
- nell’ipotesi di acquisizioni di rilevanti dimensioni promosse da più di un fondo ovvero laddove il fondo/socio fondatore uscente scelga di reinvestire con una quota di minoranza, per disporre di un veicolo di investimento comune, al fine di costituire una joint venture con altri investitori o con il fondo/socio fondatore uscente, a seconda dei casi;
- a consentire ai manager della target di partecipare all’investimento;
- a segregare l’investimento assegnandolo a una società che non possiede altre attività, con l’effetto di limitare l’esposizione al rischio del fondo, in quanto eventuali azioni condotte dai creditori nei confronti della holding in qualità di socio di controllo dell’acquisita non sono suscettibili di intaccare gli altri beni detenuti dal fondo;
- laddove l’acquisizione richieda l’assunzione di un debito subordinato, per ottenere la subordinazione strutturale del debito collocato al livello della suddetta holding rispetto al debito senior acceso dal veicolo utilizzato per l’acquisizione (bidco) che, a seguito della successiva fusione della bidco con la target, viene assunto direttamente dalla società obiettivo;
- per fornire un pacchetto di garanzie più articolato, offrendo il pegno sulle azioni di più veicoli.
A seguito del completamento dell’operazione, i fondi ottengono la remunerazione del proprio investimento sia attraverso la distribuzione dei dividendi provenienti dalla società target nel corso della durata dell’investimento, sia, dopo un orizzonte temporale di medio termine, dalla plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione nella società target.
Concentrando l’attenzione sui dividendi, sotto il profilo fiscale, gli utili distribuiti dalle società italiane alle proprie controllanti fiscalmente residenti in altri Paesi dell’Unione europea godono dell’esenzione da ritenuta di cui all’art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 che ha recepito in Italia la Direttiva madre-figlia. Dalla considerazione delle predette caratteristiche/funzioni delle holding costituite dai fondi di private equity ci sembra chiaro che la loro costituzione dipenda da obiettive esigenze di carattere strategico-organizzativo che nulla hanno a che vedere con un abuso della Direttiva madre-figlia. Ne consegue che, quand’anche fosse dimostrato che i dividendi distribuiti a favore della società madre europea defluiscano sistematicamente lungo la catena di società fino a giungere al fondo promotore dell’investimento, tale circostanza non dovrebbe essere sufficiente per negare i benefici della Direttiva madre-figlia giacché la distribuzione dei proventi a favore dei soci rientra nei compiti istituzionali di qualsiasi società[9].
Una trasposizione acritica degli elementi enunciati dalla Corte per analizzare il carattere abusivo di una struttura nell’ambito delle verifiche condotte nei confronti delle società italiane facenti capo a fondi di private equity, rischia di penalizzare ingiustificatamente tale settore mettendo in dubbio la possibilità per le holding intermedie localizzate nell’Unione europea di beneficiare del regime di esonero previsto dalla Direttiva madre-figlia anche in situazioni pienamente genuine in cui non dovrebbe esserci dubbio circa le ragioni extra-fiscali che giustificano la costituzione dei suddetti veicoli intermedi.
La mera valorizzazione del fatto che i dividendi incassati dalle società veicolo vengano – talvolta (quasi) immediatamente – fatti risalire lungo la catena partecipativa potrebbe portare, infatti, i verificatori a negare la sostanza economica delle società coinvolte e a ritenere la loro costituzione meramente finalizzata all’ottenimento del beneficio della Direttiva madre-figlia. Siffatto modus operandi avrebbe come effetto ultimo quello di richiedere l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 in capo al fondo[10] in applicazione di un approccio look through, con evidente discriminazione dei fondi esteri rispetto ai fondi istituiti in Italia[11], i quali viceversa non sono assoggettati ad imposizione né sui dividendi né sulle plusvalenze realizzate sugli investimenti effettuati in Italia.
3. La discriminazione dei fondi di investimento esteri rispetto a quelli istituiti in Italia in tema di tassazione dei dividendi
Con riferimento al regime impositivo dei fondi istituiti in Italia si osserva che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 255/2010, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia sono ricompresi tra i soggetti residenti di cui all’art. 73 del T.U.I.R. e sono pertanto soggetti passivi dell’IRES. Tuttavia, il comma 5-quinquies del medesimo art. 73 prevede che i redditi di tali organismi siano esenti dall’IRES a condizione che l’organismo collettivo, ovvero il soggetto incaricato della gestione, sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Inoltre, i fondi, qualificandosi come soggetti “lordisti”, salvo talune eccezioni, non subiscono alcuna ritenuta sui redditi di capitale percepiti. In particolare, per quanto di rilievo in questa sede, si evidenzia che nei confronti dei fondi istituiti in Italia non si applica la ritenuta sui dividendi prevista dall’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973.
Viceversa, i dividendi corrisposti da società residenti a favore di OICR esteri restano soggetti a ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta, nella misura del 26% ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Parimenti, sono assoggettate ad imposizione in Italia le plusvalenze realizzate per effetto della vendita di partecipazioni in società residenti, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. f) del T.U.I.R.[12].
Al fine di verificare se una simile discriminazione costituisca una limitazione vietata alle libertà fondamentali sancite dal Trattato occorre ulteriormente accertare se la differenza di trattamento riguardi situazioni oggettivamente comparabili o se sia comunque giustificata da ragioni imperative di interesse generale.
Sul punto soccorre l’ampia giurisprudenza comunitaria che, in più occasioni, si è espressa circa il tenore discriminatorio di regimi impositivi che trattano in modo differente i fondi istituiti nel Paese della fonte del reddito rispetto a quelli istituiti all’estero, dichiarandoli incompatibili con le libertà fondamentali sancite dal Trattato e, in particolare, con la libera circolazione dei capitali di cui all’art. 63 del TFUE. Tra le ultime pronunce giurisprudenziali si ricordano le sentenze relative alle Cause C-480/16, Fidelity Funds e C-156/17, Ka Deka.
La prima pronuncia (sentenza 21 giugno 2018, causa C-480/16, Fidelity Funds) riguardava la disciplina fiscale danese che accordava l’esonero da ritenuta sui dividendi percepiti dagli organismi di investimento residenti subordinandola alla condizione che tali organismi effettuassero una distribuzione minima (reale o presunta) nei confronti degli investitori sulla quale era operata una ritenuta a titolo d’imposta, negando viceversa tale esonero agli organismi esteri.
In quella sede la Corte ha riconosciuto che, in linea di principio, siffatta discriminazione potrebbe essere giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del sistema fiscale in quanto nel caso di specie il vantaggio concesso agli organismi di investimento residenti sarebbe compensato dalla ritenuta prelevata a carico degli investitori. Tuttavia, tale giustificazione non è stata ritenuta proporzionata in quanto sarebbe comunque possibile preservare la coerenza del sistema fiscale interno accordando l’esonero da ritenuta anche agli organismi di investimento esteri, a condizione che le autorità fiscali danesi si accertino, con la piena collaborazione di tali organismi, che questi ultimi versino un’imposta equivalente a quella versata dai fondi danesi.
Nella stessa sentenza, peraltro, la Corte, ha messo in evidenza come, per stessa ammissione del Governo danese[13], la norma in discussione si propone di assicurare l’uguaglianza tra l’onere fiscale gravante sui soggetti che investono direttamente in società con sede in Danimarca con quello gravante sui soggetti che investono tramite un fondo, evitando in questo modo i fenomeni di doppia imposizione che si verificherebbero se i dividendi fossero assoggettati ad imposta prima in capo al fondo e poi una seconda volta in capo ai detentori delle quote dello stesso. Ebbene, il rifiuto opposto dalla Danimarca di accordare l’esonero ai fondi residenti in un altro Stato membro che soddisfano le condizioni poste dalla normativa domestica conduce ad una imposizione a catena dei dividendi che contrasta con lo stesso obiettivo della normativa domestica[14].
Ugualmente la Corte ha rigettato la motivazione, fondata sulla necessità di garantire la corretta ripartizione del potere impositivo, secondo cui obbligare la Danimarca ad accordare l’esenzione da ritenuta sui dividendi distribuiti ai fondi non residenti, senza che la stessa possa prelevare un’imposta in occasione della successiva distribuzione a favore dei detentori delle quote del fondo equivarrebbe a privare lo Stato della fonte della possibilità di esercitare la competenza impositiva sui redditi prodotti sul proprio territorio.
A questo proposito, si sottolineano due affermazioni della Corte che paiono di estrema rilevanza e che dovrebbero essere tenute in considerazione quando si tratta di valutare – anche in chiave antiabusiva – il trattamento fiscale applicabile in situazioni transfrontaliere:
- in primo luogo, la Corte ha evidenziato che l’esonero da imposizione sui dividendi in uscita non può essere negato, laddove tale esonero sia riconosciuto ad un fondo residente, semplicemente a motivo dell’impossibilità di prelevare tale imposta sulle successive distribuzioni effettuate da tali organismi. E ciò in quanto, un simile comportamento non sarebbe finalizzato a preservare la propria potestà impositiva, ma finirebbe piuttosto per espandere la competenza tributaria oltre i propri confini in contrasto con il predetto principio della ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri[15];
- la Corte, inoltre,ha osservato come la potestà impositiva danese non sia stata pregiudicata nel caso di specie in quanto i dividendi distribuiti dalle società residenti in Danimarca sono già stati ivi assoggettati a tassazione a titolo di utili in capo alla società che li ha prodotti[16].
Nella più recente pronuncia (sentenza 30 gennaio 2020, Causa C-156/17, Ka Deka), invece, i giudici sono stati chiamati a giudicare la legittimità della normativa dei Paesi Bassi sulla tassazione dei dividendi corrisposti a fondi di investimento istituiti in Germania, rispetto a quella riservata ai fondi istituiti nei Paesi Bassi. In particolare la norma olandese garantiva l’esenzione dalle ritenute sui dividendi a quei fondi che rispettavano alcuni requisiti (i.e. vincoli concernenti la composizione degli investitori, impegno a distribuire i proventi percepiti entro un determinato arco temporale dalla chiusura dell’esercizio e di operare una ritenuta a titolo d’imposta su tali distribuzioni) senza apparentemente distinguere tra fondi istituiti nei Paesi Bassi e fondi istituiti all’estero. Dal testo della sentenza emerge, però, che i fondi istituiti in Germania non potevano usufruire della medesima esenzione garantita ai fondi istituiti nei Paesi Bassi in quanto: (i) non erano in grado di fornire la prova in merito al rispetto dei vincoli di composizione degli investitori previsti dalla disciplina olandese e (ii) sebbene secondo la normativa tedesca fossero tenuti a determinare un importo presunto di proventi che si considera in ogni caso distribuito e che viene tassato in capo agli investitori unitamente agli eventuali altri proventi realmente distribuiti, non erano obbligati a distribuire integralmente il risultato di gestione entro un predeterminato arco temporale.
Al di là degli specifici ed interessanti spunti che la Corte offre nella fattispecie considerata[17], ai fini che qui rilevano, preme sottolineare che i giudici comunitari hanno dichiarato la normativa olandese incompatibile con le libertà sancite dal Trattato chiarendo che, affinché venga esclusa la sussistenza di una restrizione alla libertà di circolazione non basta accertarsi che la normativa interna dello Stato della fonte si applichi alle stesse condizioni ai fondi residenti e a quelli non residenti. La Corte, infatti, ha evidenziato che subordinare la possibilità di ottenere un beneficio fiscale al rigoroso rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale, a prescindere dalle condizioni di legge alle quali i fondi di investimento non residenti sono assoggettati nel loro Stato di stabilimento, equivarrebbe a riservare ai soli fondi di investimento residenti la possibilità di beneficiare di un trattamento favorevole dei dividendi[18]. Pertanto, è necessario verificare che la presenza di tali vincoli non renda di fatto inapplicabile la norma a soggetti residenti in Paesi terzi.
Sulla scorta dei principi desumibili dalle sentenze citate[19], ci pare di poter affermare che il regime italiano di tassazione dei dividendi, trattando in modo differente i fondi regolamentati istituiti in Italia rispetto a quelli istituiti all’estero soggetti ad analoga regolamentazione, comporti una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
Peraltro, a differenza dei casi esaminati nelle due sentenze prima commentate, la normativa nazionale non subordina l’esenzione dalla ritenuta a favore dei fondi italiani ad alcun obbligo di redistribuzione dei suddetti dividendi ai detentori delle quote del fondo, con ciò confermando che, in base alla normativa nazionale, a differenza dei due casi sopra esaminati, non sussiste alcuna correlazione tra il diritto dei fondi a beneficiare dell’esenzione e la tassazione operata a carico dei detentori delle quote mediante la ritenuta operata dal fondo stesso.
Da ciò discende che nel caso italiano, il confronto finalizzato ad accertare la sussistenza di una discriminazione contraria all’ordinamento comunitario dovrebbe essere effettuato unicamente al livello del fondo, senza prendere in considerazione anche la situazione dei titolari delle quote. Tale principio è stato affermato in casi analoghi dalla stessa Corte di Giustizia la quale ha chiarito che laddove “il criterio distintivo stabilito da tale normativa, [è] basato unicamente sul luogo di residenza dell’OICVM, la valutazione della comparabilità delle situazioni ai fini della determinazione del carattere discriminatorio o meno della normativa di cui trattasi va effettuata unicamente a livello del veicolo di investimento”[20].
In ogni caso, quand’anche si volesse prendere in considerazione anche il carico fiscale in capo agli investitori, gli organismi di investimento estero risulterebbero comunque discriminati rispetto a quelli italiani. E ciò in quanto, la norma interna accorda un ampio regime di esonero ai proventi distribuiti dagli OICVM italiani stabilendo che non siano soggetti a ritenuta i proventi percepiti, fra gli altri, dagli investitori istituzionali stabiliti in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni con l’Italia (c.d. White list)[21]. Ne consegue che la restrizione non potrebbe essere giustificata neppure dalla volontà di preservare la coerenza del sistema fiscale in quanto – come già sostenuto dalla Corte nella sentenza sulla Causa C-480/16, Fidelity Funds – il medesimo obiettivo potrebbe essere perseguito, senza dar luogo ad ingiustificate forme di discriminazione, semplicemente accertando, con la collaborazione dell’organismo di investimento estero, che i relativi investitori siano localizzati in Stati White list.
Inoltre, considerato che l’art. 73, comma 5-quinquies del T.U.I.R., subordina l’esonero dall’IRES dei fondi istituiti in Italia alla condizione che il fondo ovvero il soggetto incaricato della sua gestione sia sottoposto a vigilanza, al fine di garantire la comparabilità degli organismi di investimento estero con gli analoghi organismi italiani occorrerà verificare che i fondi esteri (ovvero il soggetto incaricato della loro gestione) siano soggetti nel loro Paese a forme di vigilanza equivalenti a quelle previste dalla normativa interna[22].
Da ciò consegue che, in ossequio ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia in un’altra causa[23], siffatta discriminazione dovrebbe poter essere invocata solo da quei fondi istituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. E ciò in quanto l’autorità fiscale italiana dovrebbe essere messa in condizione di ricorrere alla cooperazione con l’amministrazione fiscale dell’altro Stato al fine di verificare che l’organismo non residente, stante le sue caratteristiche, sia qualificabile alla stregua di un organismo collettivo di investimento e che sia assoggettato a forme di vigilanza equivalenti a quelle vigenti in Italia.
4. La possibilità di estendere il principio di non discriminazione ai fondi istituiti in Paesi terzi
Una volta appurata l’esistenza di una ingiustificata restrizione a danno dei fondi esteri rispetto a quelli istituiti in Italia occorre ulteriormente verificare se tale restrizione possa essere denunciata anche da fondi localizzati fuori dall’Unione europea.
A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il trattamento fiscale dei dividendi può ricadere tanto nella sfera di applicazione dell’art. 49 TFUE riguardante la libertà di stabilimento di cui possono avvalersi solo i soggetti stabiliti nell’Unione europea quanto nella sfera di applicazione dell’art. 63 TFUE, che vieta qualsiasi restrizione alla libera circolazione dei capitali sia tra Stati membri sia con Paesi terzi.
In tale contesto, sempre secondo le indicazioni della Corte, per stabilire se la normativa nazionale ricada sotto l’una o sotto l’altra delle libertà sancite dal Trattato occorre prendere in considerazione l’oggetto della normativa[24].
In particolare, secondo l’insegnamento della Corte, una normativa destinata ad applicarsi esclusivamente alle partecipazioni che consentono di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e di determinarne le attività rientra nella sfera di applicazione della libertà di stabilimento. Viceversa, eventuali disposizioni nazionali applicabili a partecipazioni effettuate al solo scopo di realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influire sulla gestione e sul controllo dell’impresa, devono essere esaminate esclusivamente alla luce della libera circolazione dei capitali[25].
Se, invece, la normativa nazionale si applica a prescindere dall’entità della partecipazione, stabilire quale delle due libertà prevalga diventa più complesso. In simili circostanze, con riferimento ai dividendi “in entrata”, la Corte, per lungo tempo, ha ritenuto che dovesse farsi riferimento ai fatti oggetto del procedimento principale. Pertanto, se dai fatti si desumeva che una persona deteneva una partecipazione che le consentiva di esercitare una sicura influenza sulle decisioni della società sita nel Paese terzo, il caso sarebbe rientrato nell’ambito della libertà di stabilimento con la conseguenza che siffatta persona non avrebbe potuto invocare né la libertà di circolazione in quanto ritenuta inapplicabile né la libertà di stabilimento in quanto questa non si estende ai rapporti con i Paesi terzi.
La Corte, nella sua formazione di Grande Sezione, ha tuttavia modificato tale impostazione nella sentenza del 13 novembre 2012, Causa C-35/11, Test Claimants in the FII Group Litigation[26].
In base a tale più recente impostazione, invece, i fatti in causa non sono decisivi al fine di individuare la libertà applicabile, dovendosi privilegiare l’esame dell’oggetto della normativa nazionale. Se da tale esame risulta che la normativa nazionale non si applica esclusivamente alle fattispecie nelle quali la società madre eserciti un’influenza determinante sulla società che distribuisce i dividendi, il giudizio sarà formulato alla luce dell’art. 63 TFUE, anche in presenza di una partecipazione di controllo. La Corte desume una conferma del fatto che non occorra porre riferimento alle “particolari circostanze del caso di specie” (e che, quindi, la causa può essere decisa in base ai principi di libera circolazione dei capitali anche quando nei fatti si discuta pacificamente di partecipazioni controllo), dall’art. 64, paragrafo 1 del TFUE. Tale disposizione autorizza il mantenimento nei confronti dei Paesi terzi delle restrizioni ai movimenti di capitali implicanti uno stabilimento o investimenti diretti in vigore alla data del 31 dicembre 1993. La Corte osserva che tale disposizione sarebbe inutiliter data se non si assumesse che anche gli investimenti di maggioranza che implicano lo stabilimento o un investimento diretto siano ricompresi nella nozione di libera circolazione dei capitali.
Tale (nuova) impostazione, inizialmente formulata dalla Corte nella sentenza sulla Causa C- 35/11, Test Claimants in FII Group Litigation avente ad oggetto il trattamento fiscale dei dividendi originari di Paesi terzi, è stata successivamente estesa anche al pagamento di dividendi “in uscita”. In particolare, nella già citata Causa C-190/12, DFA Investment Trust Company, la Corte ha espressamente riconosciuto che, laddove la norma che esonera da imposizione i dividendi pagati a favore di fondi nazionali non opera distinzioni in funzione dell’entità della partecipazione da cui sono scaturiti i dividendi, il pagamento dei suddetti dividendi a favore di fondi esteri istituiti in Paesi terzi ricade nell’ambito di applicazione della libera circolazione di capitali, con la conseguenza che eventuali restrizioni potranno essere denunciate anche in relazione ai dividendi percepiti da fondi istituiti in Stati terzi che detengono partecipazioni di controllo in società residenti all’interno dell’Unione europea[27].
Dopo avere esteso l’applicazione della libera circolazione dei capitali alle partecipazioni di controllo, la Corte, tuttavia, precisa che occorre evitare che tale interpretazione estensiva dell’art. 63 del TFUE“consenta agli operatori economici che non ricadono all’interno della sfera di applicazione territoriale della libertà di stabilimento di giovarsi di quest’ultima”[28]. Tuttavia, la Corte ritiene che tale rischio non ricorra nel caso in esame “considerato che la normativa tributaria oggetto del procedimento principale riguarda il trattamento fiscale di tali dividendi e non è volta a subordinare a condizioni l’accesso al mercato nazionale degli operatori provenienti da paesi terzi”[29].
Seguendo tale imposizione, posto che la norma contenuta nell’art. 73, comma 5-quinquies del T.U.I.R. che esonera da imposizione i fondi comuni soggetti a vigilanza è del tutto indipendente dall’entità delle partecipazioni detenute dai suddetti fondi, nel caso in esame il pagamento di dividendi a favore di fondi esteri dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della libertà di circolazione dei capitali, con la conseguenza che la restrizione prima esaminata potrebbe essere invocata anche in relazione ai dividendi distribuiti a favore di fondi localizzati in Stati terzi.
4.1 Clausola di “standstill”
Una volta accertata l’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali, occorre verificare l’eventuale applicazione della clausola di standstill la quale lascia impregiudicata l’applicazione, agli Stati terzi, delle restrizioni ai movimenti di capitali implicanti uno stabilimento o investimenti diretti in vigore alla data del 31 dicembre 1993[30].
Con riferimento alla verifica dell’elemento temporale, la giurisprudenza della Corte ha chiarito che per ricadere nella suddetta deroga occorre che “la restrizione di cui trattasi abbia fatto ininterrottamente parte dell’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato a partire da tale data (31 dicembre 1993 – N.d.R.)” e che non è possibile “reintrodurre restrizioni … che erano in vigore nell’ordinamento giuridico nazionale alla data del 31 dicembre 1993, ma che non sono state mantenute”[31]. Nel caso di modifiche normative succedutesi nel tempo, la Corte ha precisato che rientrano nella clausola derogatoria anche misure nazionali adottate posteriormente al 1993, quando si tratti di “disposizioni sostanzialmente identiche ad una legislazione anteriore o che si limitino a ridurre o ad eliminare ostacoli all’esercizio dei diritti e delle libertà comunitarie che esistevano nella legislazione precedente” restando, viceversa, escluse quelle “disposizioni che si basino su una logica diversa da quella del diritto precedente e che istituiscano nuove procedure”[32].
Tanto premesso, occorre ripercorrere brevemente il regime fiscale dei fondi istituti in Italia per verificare se, anche alla luce dei principi giurisprudenziali prima sinteticamente illustrati, nel caso in esame, si tratti di una restrizione già esistente alla predetta data o introdotta successivamente.
Rammentiamo preliminarmente che, a decorrere dal 1° luglio 2011, il D.L. n. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011, ha riformato radicalmente il regime fiscale degli organismi di investimento italiani, prevedendo – come già detto – che questi fossero soggettivamente esenti dall’IRES, mantenendo al contempo la qualifica di soggetti “lordisti” con riferimento ai dividendi distribuiti da società residenti. Di conseguenza, per effetto della suddetta modifica normativa, i dividendi percepiti da fondi italiani non scontano alcuna imposizione, mentre i dividendi distribuiti a favore di fondi esteri sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%.
Con riferimento al regime previgente, osserviamo che, alla data del 31 dicembre 1993, in base alla normativa allora in vigore, i fondi comuni italiani subivano una ritenuta a titolo d’imposta sui dividendi percepiti, alla stessa stregua dei fondi esteri. Di conseguenza, al di là di possibili differenze di aliquote, sia i fondi esteri sia i fondi italiani erano tassati in relazione ai dividendi distribuiti da società residenti in Italia[33]. Il regime fiscale non ha subito modifiche “sostanziali” per effetto della riforma recata dal D.Lgs. n. 461/1997, giacché da un lato è stata riconosciuta ai fondi la qualifica di soggetti “lordisti” con la conseguenza che i fondi non subivano alcun prelievo alla fonte sui dividendi percepiti i quali, però, erano comunque assoggettati ad imposizione in capo al fondo mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione[34].
Il quadro normativo è stato radicalmente modificato per effetto del D.L. n. 225/2010 che ha previsto – a determinate condizioni – una forma di esonero “soggettivo” da imposizione a favore dei (soli) organismi di investimento italiani. Da ciò consegue che, anche volendo ammettere che la restrizione sussistesse già al 31 dicembre 1993, in quanto in relazione ai dividendi di fonte italiana i fondi esteri erano assoggettati a tassazione con un’aliquota superiore a quella prevista per i fondi nazionali, il D.L. n. 225/2010 non si è limitato a riprodurre una disposizione sostanzialmente analoga a quella prevista nella legislazione precedente, ma ha introdotto una restrizione più pesante sotto il profilo quantitativo e basata su una logica affatto diversa da quella del diritto precedente. Pertanto, una simile modifica normativa non rientra tra quelle coperte dalla clausola di standstill.
Da ultimo, una volta accertato che nel caso in esame non opera la clausola di standstill, occorre verificare se una simile restrizione possa essere giustificata dalla necessità di garantire l’efficienza dei controlli fiscali, anche in considerazione della circostanza che i movimenti di capitali tra Stati membri e Stati terzi si collocano in un “contesto giuridico differente”, soprattutto per quanto concerne l’assistenza amministrativa. A questo proposito, mutuando le considerazioni svolte dalla Corte nella causa C-190/12, DFA Investment Trust Company, riteniamo che tale giustificazione non sia ammissibile nei casi in cui esista – anche in base alla normativa convenzionale – un adeguato scambio di informazioni con il Paese estero dove il fondo (ovvero il suo gestore/advisor) è istituito che consenta alle Autorità fiscali italiane di verificare che il fondo (ovvero il suo gestore/advisor) sia soggetto a forme di vigilanza analoghe a quelle previste dalla normativa nazionale e che l’organismo estero, a prescindere dalla sua forma giuridica, possieda i requisiti essenziali per configurare una forma di gestione collettiva del risparmio.
5. Conclusioni
Una volta acclarato, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, che l’applicazione di ritenute in uscita sui dividendi distribuiti da società italiane a favore di fondi esteri soggetti a vigilanza implica una ingiustificata limitazione alla libertà di circolazione dei capitali, vi è da chiedersi se sia corretto che l’applicazione di una normativa (quale l’art. 27-bis, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973) adottata per recepire nel diritto interno una direttiva comunitaria[35], possa condurre ad un risultato in contrasto con il diritto primario dell’Unione.
Secondo un consolidato principio accolto dalla giurisprudenza comunitaria, “qualsiasi misura nazionale in un ambito che ha costituito oggetto di un’armonizzazione esauriente a livello dell’Unione dev’essere valutata alla luce delle disposizioni di questa misura di armonizzazione, e non di quelle del diritto primario”[36]. In linea di principio, quindi non dovrebbe essere escluso che una norma secondaria, come una direttiva, possa limitare una delle libertà garantite dal Trattato. Si tratta però di stabilire se la disposizione contenuta nell’art. 1, paragrafi 2, 3 e 4 della Direttiva madre-figlia realizzi una siffatta armonizzazione esauriente. Con riferimento alla previgente versione dell’art, 1, paragrafo 2 della Direttiva madre-figlia (che conteneva una disposizione identica a quella oggi contenuta nel paragrafo 4), la Corte nella sentenza C-6/16 ha chiarito che tale disposizione, la quale riconosce agli Stati membri unicamente il potere di applicare le disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi, non realizza una misura di armonizzazione esauriente[37]. Ne consegue quindi che siffatte disposizioni possono essere valutate anche alla luce del diritto primario dell’Unione. Sebbene la Direttiva madre-figlia sia stata successivamente oggetto di modifiche che hanno introdotto nel corpo della stessa Direttiva una misura antiabuso specifica[38], riterremmo che tale norma, rappresentando una misura di armonizzazione minima, lasci ampi spazi di discrezionalità al legislatore nazionale che resta libero di introdurre misure più rigide, con la conseguenza che tali disposizioni nazionali di recepimento dovrebbero essere valutate anche alla luce del diritto primario[39].
Con ciò non si vuole evidentemente utilizzare il diritto primario dell’Unione per sottrarsi alle misure antiabuso introdotte per impedire di avvalersi in modo fraudolento dei diritti sanciti dalla Direttiva[40]. Semmai, si tratta di valutare se possa considerarsi abusivo l’utilizzo di una holding intermedia costituita in uno Stato membro, laddove la sua costituzione – oltre a tutte le ragioni economiche ed organizzative prima evidenziate – possa essere motivata anche dalla volontà di prevenire una discriminazione contraria alla libera circolazione dei capitali, conseguente al mancato adeguamento della normativa nazionale ai principi comunitari.
Relativamente alla nozione di abuso, sebbene sul punto l’impostazione della Corte di Giustizia non sia del tutto univoca, siamo inclini a ritenere che nessun abuso possa essere contestato laddove la struttura dell’operazione non dia luogo ad alcun risparmio fiscale[41]. Da ciò consegue che, nel caso di specie, al fine di valutare l’eventuale artificiosità della holding intermedia dovrebbe essere posto a confronto il carico fiscale sopportato in base alla struttura prescelta con quello che sarebbe stato applicato laddove i dividendi fossero stati percepiti direttamente dal beneficiario effettivo, senza l’intervento della holding intermedia. Laddove da tale confronto non emerga alcun risparmio d’imposta, in quanto i dividendi sarebbero stati comunque esonerati da imposizione in base alla normativa interna o convenzionale, non dovrebbe residuare spazio per contestazioni fondate sulla norma antiabuso, e ciò a prescindere da qualsiasi valutazione in merito alla “sostanza” della holding intermedia[42].
Ciò posto, si tratta di stabilire se ai fini del suddetto confronto si debba fare riferimento esclusivamente alla normativa interna pro tempore vigente o se, come pare più corretto, si possano (rectius: debbano) tenere in considerazione anche le modifiche necessarie per allineare tale normativa nazionale ai principi comunitari. A sostegno di quest’ultima impostazione depone il principio del primato del diritto comunitario che impone a tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alla normativa nazionale (e, quindi, sia agli organi giurisdizionali sia a quelli amministrativi) di garantire la piena efficacia del diritto comunitario “disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”[43]. È evidente che ove si acceda a questa impostazione nel caso in esame dovrebbe essere senz’altro esclusa qualsiasi forma di abuso, posto che i dividendi distribuiti, in ultima istanza, a favore di un fondo comune di investimento estero assoggettato a regolamentazione avrebbero potuto comunque beneficiare dell’esonero dalla ritenuta alla fonte in ossequio ai principi comunitari, ampiamente commentati ai paragrafi precedenti, che impongono di eliminare le discriminazioni a danno dei fondi esteri che si trovano in una situazione comparabile a quella di un fondo italiano.
Tale conclusione non ci sembra in contrasto con l’affermazione fatta dalla Corte secondo cui “una società residente in uno Stato membro non può rivendicare … il beneficio delle libertà sancite dal Trattato FUE per mettere in discussione la normativa nazionale posta a disciplina della tassazione dei dividendi corrisposti ad una società residente in un altro Stato membro”[44]. Infatti, in questo il caso, i principi fondamentali del diritto dell’Unione non vengono invocati per sottrarsi alle misure antiabuso nazionali introdotte per impedire di avvalersi in modo fraudolento dei diritti sanciti dalla Direttiva, bensì – in una fase logicamente precedente – per accertare la sussistenza di un abuso.
Parimenti, non sembra del tutto appropriato il riferimento al principio sancito dalla giurisprudenza comunitaria secondo cui, in presenza di una “armonizzazione esauriente”, non è possibile invocare le libertà fondamentali sancite dal Trattato per sottrarsi alle disposizioni contenute in una Direttiva o nelle relative norme di recepimento.
Per fare un esempio concreto, si pensi al caso di una società chiaramente radicata nel Paese di insediamento (in termini di personale impiegato, locali, attrezzature, struttura dei costi) la quale interviene in una operazione di dividend washing. In questo caso, una volta accertata la natura abusiva dell’operazione di dividend washing laddove questa, in ragione del preciso collegamento tra le due operazioni di vendita e retrocessione del titolo, dia luogo ad un risparmio fiscale indebito, non potrebbe essere invocata la libertà di stabilimento di cui gode la società in virtù del suo radicamento nel Paese per pretendere l’esonero da imposizione dei dividendi ai sensi della Direttiva madre-figlia.
La fattispecie in esame è tutt’affatto diversa. In questo caso, infatti, le libertà fondamentali sancite dal Trattato non vengono invocate per sottrarsi alle disposizioni contenute nella Direttiva o nelle relative norme di recepimento, quanto piuttosto al fine di interpretare correttamente la Direttiva ed individuarne l’ambito di applicazione, anche alla luce del principio del divieto di pratiche abusive.
[1] L. Rossi e M. Ampolilla, Le holding nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Bollettino Tributario n. 3-2020, p. 189
[2] Cfr. Sentenza Cause riunite C-116/16 e 117/16, punto 101.
[3] Cfr. Sentenza Cause riunite C-116/16 e 117/16, punto 103.
[4] Cfr. Sentenza Cause riunite C-116/16 e 117/16, punto 104.
[5] Cfr. Sentenza Cause riunite C-116/16 e 117/16, punto 105.
[6] Cfr. Sentenza Cause riunite C-116/16 e 117/16, punto 105.
[7] In particolare, sorprende che la Corte non abbia nemmeno menzionato la precedente sentenza20 dicembre 2017, pronunciata nelle Cause riunite C-504/16 e C-613/16, Deister Holding e Juler Holding, con la quale era stata espressamente riconosciuta la genuinità di una società la cui attività consisteva nella mera detenzione e amministrazione di partecipazioni in società figlie evidenziando che, in tal caso, il giudizio sull’eventuale artificiosità della struttura deve tenere conto di variabili come le funzioni organizzative ed economiche svolte dalla società madre all’interno del gruppo.
[8] In questo senso, si vedano le considerazioni svolte dall’Assonime in Note e Studi n. 10/2020 la quale rileva che “per accertare la legittimità dell’esistenza della holding passiva, le sentenze fanno riferimento ad elementi poco significativi (quali il personale dipendente, i costi, i locali e le attrezzature)“ e che sarebbe invece più corretto a questi fini “fare riferimento … alle funzioni di supporto al gruppo che la holding assicura“ e fra le quali rientrano “la segregazione del rischio, realizzazione di investimenti, strumento per operazioni riorganizzative del gruppo, funzioni di garanzia, ecc.”.
[9] Nel Commentario all’art. 10 del Modello di convenzione OCSE una simile giustificazione è utilizzata con riferimento ai fondi pensione o ad altri organismi di investimento collettivo sottolineando che le distribuzioni effettuate da tali soggetti per soddisfare le obbligazioni nei confronti dei propri quotisti non fanno perdere a tali soggetti la qualità di “beneficiari effettivi” in quanto sono connaturate alla funzione svolta da tali organismi, ed inoltre non sussiste una specifica correlazione/dipendenza tra il pagamento ricevuto e il successivo obbligo di redistribuzione. Sul punto si veda anche Note e Studi Assonime n. 13/2020 nella quale si sottolinea che il concetto di beneficiario effettivo (beneficial owner o semplicemente BO) non dovrebbe essere “inteso eccessivamente tecnico, nel senso cioè di individuare il BO nei soggetti (destinatari) finali dei flussi (le persone fisiche socie della società, etc.), ma nei soggetti che ricevendo i pagamenti ne possono disporre liberamente secondo i propri compiti istituzionali [sottolineatura aggiunta, n.d.r.]”. La stessa Associazione di categoria, nella precedente Note e Studi n. 10/2020 sottolinea come dal testo definitivo delle modifiche operate nel 2014 al Commentario al Modello di Convenzione OCSE, soprattutto se posto a confronto con le modifiche inizialmente proposte nel documento di consultazione del 2011 che richiedevano il potere di usare e godere del dividendo in modo pieno e assoluto (“the full right to use and enjoy the dividend [sottolineatura aggiunta, n.d.r.]”), si evinca che la qualità di beneficiario effettivo non deve essere negata ogni qual volta il percettore ritrasferisca il flusso ricevuto ad un terzo, ma solo quando sussiste una “correlazione” tra la percezione di un determinato flusso e l’obbligo – anche meramente fattuale e non scritto – di ritrasferire proprio quel flusso ad un terzo. A proposito delle distribuzioni lungo le catene partecipative, come evidenziato dall’Assonime, nel documento preparatorio di consultazione del 2012 si dava atto che gli operatori del settore avevano risposto alla consultazione osservando che il c.d. dividend sweeping, ossia la situazione in cui una società capogruppo richiede alle società controllate di più basso livello nella catena partecipativa di distribuire gli utili per concentrare le risorse necessarie per effettuare nuovi investimenti ovvero per consentire la regolare distribuzione di dividendi agli azionisti nel caso di società quotate, non dovesse comportare la perdita dello status di beneficiario effettivo.
[10] Si ricorda che i fondi c.d. non-CIV (quali i fondi di private equity) non sono oggetto di specifica disamina nel Commentario al Modello di Convenzione di OCSE. Pertanto, è dubbio se e a quali condizioni tali fondi possano godere dei benefici convenzionali che generalmente, per quanto concerne i dividendi, garantiscono l’applicazione di una ritenuta inferiore a quella prevista dall’art. 27 del D.P.R. n. 600/1972, nonché attribuiscono la potestà impositiva sulle plusvalenze relative a partecipazioni in società diverse da quelle immobiliari, allo Stato di residenza. Sull’argomento, si veda, C. Galli e S. Mancinelli, L’applicazione ai fondi esteri delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, in Corriere Tributario, n. 13 – 2018, pag. 1017 e segg..
[11] La predetta discriminazione è stata più volte oggetto di interventi in dottrina (si veda, tra gli altri, M. Antonini e C. Setti della Volta, Ritenute sui dividendi in uscita e fondi di investimento non residenti ancora una incompatibilità UE – il commento, in Corriere Tributario n. 30 – 2018, p. 2339).
[12] Fanno eccezione le plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate in società quotate di cui all’art. 23, comma 1, lett. f), n. 1) del T.U.I.R. e le plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate realizzate da soggetti White List ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997. Tali fattispecie però generalmente non ricorrono nel caso dei fondi di private equity i quali di norma effettuano investimenti in partecipazioni di controllo o di minoranza qualificata tali da attribuire al titolare il potere di partecipare attivamente alla gestione della partecipata.
[13] Cfr. sentenza C-480/16, punto 52 ove si osserva che “Come risulta dalle osservazioni del governo danese, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale ha l’obiettivo … di assicurare l’uguaglianza tra l’onere fiscale gravante sui singoli che investono in società con sede in Danimarca tramite un OICVM e quello gravante sui singoli che investono direttamente in società con sede in Danimarca. Tale normativa eviterebbe così una doppia imposizione economica che si verificherebbe se i dividendi fossero assoggettati a imposta in capo all’OICVM interessato e in capo ai detentori di quote dello stesso”.
[14] Si veda sentenza C-480/16, punto 85.
[15] Si veda sentenza C-480/16, punto 75. Il tema è in parte connesso al “diritto dei singoli di trarre vantaggio dalla concorrenza che s’instaura tra gli Stati membri per effetto della mancata armonizzazione della tassazione dei redditi”. Tale diritto è stato ribadito dalla Corte di Giustizia anche nelle sentenze sui c.d. casi danesi, sebbene ne venga ridimensionata la portata sottolineando che tale diritto non può superare il principio generale secondo cui le pratiche abusive sono vietate (cfr., Cause riunite C-116/16 e C-117/16, punto 80). Nello stesso senso si vedano anche le Conclusioni dell’Avvocato Generale alla Causa C-116/16 in cui si evidenziava che il fatto che l’operazione fosse “strutturata in modo tale da includere uno Stato membro che abbia rinunciato alla tassazione alla fonte, non può per questo solo fatto essere considerata abusiva” (punto 63).
[16] Si veda sentenza C-480/16, punto 72.
[17] Per un’analisi più approfondita della sentenza relativa alla Causa C-156/17 si rimanda ad A. Privitera e M. Nardini, La sentenza KA Deka e la discriminazione subita dagli OICR esteri in relazione ai dividendi di fonte italiana, in Diritto Bancario, Marzo 2020.
[18] Cfr., causa C-156/17, punto 73.
[19] Le sentenze commentate si pongono in linea con altri meno recenti precedenti quali la sentenza 18 giugno 2009, Causa C-303/07, Aberdeen; sentenza 10 maggio 2012, Cause riunite da C-338/11 a C-347/11, Santander; sentenza 10 aprile 2014, Causa C-190/12 DFA Investment Trust Company. Per l’analisi di tali precedenti sentenze sia consentito rinviare a L. Rossi e M. Ampolilla, Regime dei dividendi di fonte italiana percepiti da fondi esteri alla luce dei principi comunitari, in Corriere Tributario 2014, pag. 2014 e segg..
[20] Si vedano, la sentenza sulla Causa C-303/07, Aberdeen e la sentenza sulle Cause riunite C- 338/11 e C-347/11, Santander. La sentenza sul caso Santander aveva ad oggetto la disciplina francese la quale prevedeva una ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società francesi a favore di fondi comuni d’investimento non residenti, mentre i medesimi dividendi versati a fondi comuni nazionali non erano assoggettati a imposizione. In quella sede la Corte ha evidenziato la differenza rispetto alla fattispecie esaminata nella sentenza 20 maggio 2008, Causa C-194/06, Orange European Smallcap Fund. In quel caso, infatti, la Corte ha ritenuto di dover prendere in considerazione il regime impositivo applicabile alle persone fisiche titolari delle quote in quanto la normativa olandese oggetto della controversia subordinava l’esenzione fiscale in capo agli organismi di investimento collettivi residenti alla condizione che gli utili di tali organismi fossero integralmente distribuiti ai loro titolari, e ciò al fine di garantire una sostanziale equivalenza tra il trattamento fiscale dell’investimento diretto e quello realizzato tramite un fondo. Analoga soluzione non poteva tuttavia essere estesa – ad avviso della Corte – anche al caso francese, posto che l’unico criterio distintivo del trattamento fiscale applicabile in base alla normativa nazionale non era la situazione fiscale dei titolari delle quote, ma solo la situazione dell’OICVM, a seconda che esso fosse residente o meno in Francia (si vedano punti 39 e 40 della sentenza C- 338/11 e C-347/11, Santander).
[21] In virtù del rinvio operato dall’art. 26-quinquies, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973 ai soggetti non residenti elencati nell’art. 6 del D.Lgs. n. 239/1996, non sono soggetti ad imposta i proventi percepiti da:
- soggetti residenti in Stati e territori White list;
- enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi White list;
- banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
L’elenco dei Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni con l’Italia è contenuto nel D.M. 4 settembre 1996. Tra il 2016 ed il 2017, a seguito della stipula da parte dell’Italia di specifici accordi per lo scambio di informazioni (Tax Information Exchange Agreements o TIEA) tale elenco si è arricchito di numerosi Paesi.
[22] Relativamente al requisito della vigilanza, si osserva che – seppure con riferimento ad una normativa diversa (il quesito riguardava il regime di non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari percepiti da organismi di investimento collettivo del risparmio esteri istituiti in Paesi White list, disposto dall’art. 7, comma 3 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351) – in più di una occasione l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il requisito di vigilanza si intende soddisfatto quando il gestore o anche solo il relativo advisor sono soggetti a vigilanza.
[23] In tal senso, si veda sentenza C-190/12, DFA Investment Trust Company.
[24] Cfr., sentenza del 13 novembre 2012, C-35/11, Test Claimant in FII Group Litigation punti 89-90 e sentenza 10 aprile 2014, C-190/12 DFA Investment Trust Company, punto 25.
[25] Si vedano, in tal senso, ex pluribus, sentenze 11 febbraio 2011, Cause riunite C-436/08 e C-437/08, Haribo Salinen, e 19 luglio 2012, Causa C-31/11, Scheunemann.
[26] Si vedano, Conclusioni presentate il 6 novembre 2013 alla Causa C-190/12, DFA Investment Trust Company (punto 19), dove lo stesso Avvocato Generale Mengozzi sottolinea il revirement della giurisprudenza comunitaria. Nello stesso senso anche, P. Wattel, H&I 2013/3.1: Test Claimants in the FII Group Litigation (FII-2), il quale osserva che la pronuncia del 13 novembre 2012 è stata resa dalla Grande Sezione (composta dal presidente, vicepresidente, e da tutti i presidenti di sezione) in quanto presumibilmente la Corte era consapevole del fatto che la decisione si discostava dall’orientamento precedente. Invero, l’orientamento precedente della Corte era alquanto ondivago, posto che già in altre occasioni la Corte aveva giudicato fattispecie concernenti partecipazioni di controllo alla luce dei principi sulla libera circolazione dei capitali. Si veda, sentenza 17 settembre 2009, Causa C-182/08, Glaxo. La causa aveva ad oggetto una disposizione antiabuso tedesca che mirava a contrastare le operazioni di dividend washing realizzate da investitori esteri mediante il temporaneo trasferimento delle partecipazioni detenute in società tedesche a favore di soggetti tedeschi che beneficiavano del credito d’imposta. In quella sede, la Corte aveva giustificato la propria conclusione sulla base di un principio di “prevalenza”, osservando che laddove risulti che l’applicazione della normativa nazionale non dipende dall’entità della partecipazione e che l’obiettivo della norma è quello “di impedire ai soci non residenti di giovarsi di un beneficio fiscale che non spetta loro, sorto come diretta conseguenza di cessioni di quote che possono essere per l’appunto effettuate all’unico scopo di beneficiare di tale vantaggio e non al fine di esercitare la libertà di stabilimento o in conseguenza dell’esercizio di detta libertà, si deve ritenere che il profilo della normativa in esame relativo alla libera circolazione dei capitali prevalga su quello connesso alla libertà di stabilimento. Conseguentemente, ammesso che la normativa di cui trattasi abbia effetti restrittivi sulla libertà di stabilimento, tali effetti sarebbero l’inevitabile conseguenza di un possibile ostacolo alla libera circolazione dei capitali e, quindi, non giustificano un esame autonomo della stessa normativa alla luce dell’art. 52 del Trattato (divenuto art. 49, TFUE- N.d.R.)” (punti 50 e 51 della sentenza in commento). Seguendo questa impostazione, benché nei fatti la controversia avesse ad oggetto un’operazione realizzata all’interno del gruppo e riguardante partecipazioni di controllo, la Corte ha ritenuto che la causa andasse esaminata esclusivamente con riferimento alla libera circolazione dei capitali.
[27] Nello stesso senso, si veda anche la sentenza 24 novembre 2016, Causa C-464/14, SECIL, punto 41 avente ad oggetto il caso di dividendi percepiti da una società portoghese la quale deteneva una partecipazione pari a oltre il 90% del capitale di una società stabilita in Tunisia e una partecipazione (detenuta in parte direttamente e in parte indirettamente) pari a circa il 51% di una società stabilita in Libano. Per completezza, tuttavia, si precisa che la Corte, anche successivamente al renvirement operato con la sentenza C-35/11 Test Claimants in FII Group Litigation, in talune occasioni ha continuato ad attribuire rilevanza, al fine di individuare la libertà applicabile, ai fatti di causa. In questo senso si segnala in particolare la sentenza7 settembre 2017 C-6/16 Eqiom e Enka, punto 44.
[28] Si veda, causa C-35/11, Test Claimants in FII Group Litigation, punto 100. Nello stesso senso, Causa C-190/12, DFA Investment Trust Company, punto 31.
[29] Si veda, Causa C-190/12, DFA Investment Trust Company, punto 33. Nello stesso senso, Causa C-35/11, Test Claimants in FII Group Litigation, punto 100. Come rilevato anche in dottrina (E. Nijkeuter & M. F. de Wilde, FII and the Applicable Freedoms of Movement in Third Country Situations, in EC Tax Review, 2013/5, pag. 250), se intesa alla lettera, la considerazione svolta dalla Corte comporta che il rischio che un operatore economico si avvalga “indebitamente” della libertà di stabilimento non dovrebbe mai porsi nelle controversie riguardanti la materia fiscale, in quanto la normativa oggetto del giudizio di compatibilità rispetto ai principi comunitari non riguarda per definizione “le condizioni di accesso al mercato”, ma “unicamente il trattamento fiscale”. Secondo gli Autori citati in precedenza, tuttavia, una simile conclusione non appare accettabile, in quanto subordinare l’accesso al mercato ad una condizione (come l’ottenimento di una licenza) ovvero imporre ai soggetti esteri una tassazione più gravosa rispetto agli operatori nazionali comportano effetti restrittivi sostanzialmente analoghi sull’esercizio della libertà di stabilimento.
[30] Il tema dell’applicazione della clausola di standstill non si pone con riferimento agli investimenti di minoranza. E ciò in quanto, l’applicazione della deroga di cui all’art. 64, paragrafo 1 del TFUE presuppone che ricorrano congiuntamente due condizioni: (i) una temporale, ovvero che la restrizione fosse già in vigore al 31 dicembre 1993; e (ii) una sostanziale, ovvero che i movimenti di capitale implichino “investimenti diretti”. Come chiarito in più di una occasione dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, in mancanza di una definizione contenuta nel Trattato, al fine di chiarire la nozione di “investimenti diretti” occorre fare riferimento alle definizioni contenute nella nomenclatura dell’allegato I della direttiva 88/361/CEE del Consiglio del 24 giugno 1988 e alle sue note esplicative. In particolare gli investimenti diretti rientrano nella rubrica I della suddetta nomenclatura e includono, al punto 2, la “partecipazione a imprese nuove o esistenti al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli”. Inoltre, come chiarito nelle note esplicative, con riferimento alle imprese menzionate al suddetto punto 2 della nomenclatura “si ha partecipazione con carattere di investimento diretto, quando il pacchetto di azioni in possesso di una persona fisica, di un’altra impresa o di qualsiasi altro detentore, attribuisce a tali azionisti, sia a norma delle disposizioni di legge nazionali sulle società per azioni, sia altrimenti, la possibilità di partecipare effettivamente alla gestione di tale società o al suo controllo”. Sulla base di tale definizione, la Corte è solita distinguere tra “gli investimenti diretti sotto forma di partecipazione ad un’impresa attraverso un possesso di azioni che consenta di partecipare effettivamente alla sua gestione e al suo controllo (investimenti cd. ‘diretti’)” e “l’acquisto dei titoli sul mercato dei capitali effettuato soltanto per realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di incidere sulla gestione e sul controllo dell’impresa (investimenti cd. ‘di portafoglio’)” (si veda, ex pluribus, sentenza 17 settembre 2009, Causa C-182/08, Glaxo, punto 40). Gli investimenti di minoranza, compreso il pagamento dei dividendi che ne derivano, rappresentando investimenti “di portafoglio”, non rientrano pertanto nell’ambito della deroga di cui all’art. 64, paragrafo 1 del TFUEe non sono, quindi, coperti dalla clausola di standstill, senza che occorra a tal fine verificare la sussistenza della condizione temporale.
[31] Si veda, sentenza 18 dicembre 2007, Causa C-101/05, Skatterverket v. A, punto 48.
[32] Si veda, in tal senso, sentenza 18 dicembre 2007, Causa C-101/05, Skatterverket v. A, punto 49 e la giurisprudenza ivi richiamata.
[33] Quanto alle aliquote, si precisa che i dividendi distribuiti a favore di fondi italiani erano assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 10%. I dividendi distribuiti a favore di soggetti esteri erano assoggettati a ritenuta con l’aliquota del 32,4% (o con la minore aliquota prevista dalla Convenzione, ove applicabile). Ai sensi dell’art. 27, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973, “[i] soggetti residenti all’estero hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero”.
[34] All’epoca, l’imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione si applicava (di regola) con l’aliquota del 12,5%, mentre i dividendi distribuiti a favore di fondi esteri erano soggetti a ritenuta con l’aliquota del 27% (o con la minore aliquota prevista dalla Convenzione, ove applicabile). Restava ferma la possibilità, a certe condizioni, di richiedere il rimborso parziale della ritenuta subita.
[35] Il riferimento è alla Direttiva (UE) 2015/121 del 27 gennaio 2015 che ha modificato la direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi prevedendo l’introduzione di una misura minima antiabuso.
[36] Si veda, sentenza dell’8 marzo 2017, Euro Park Service, C‑14/16, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata.
[37] Si veda sentenza C-6/16, Eqiom, punti da 15 a 17.
[38] La clausola antielusiva specifica contenuta nella Direttiva riproduce pressoché letteralmente la norma antielusiva generale (c.d. GAAR) introdotta dall’art. 6 della Direttiva 2016/1164 (c.d. ATAD) e rappresenta una misura di armonizzazione minima (minimum standard) non essendo preclusa, in linea di principio, agli Stati membri la possibilità di introdurre norme antielusive più rigide.
[39] Considerazioni analoghe sono svolte da CFE ECJ Task Force, Opinion Statement ECJ-TF 2/2018 on the ECJ Decision of 7 September 2017 in Eqiom (Case C-6/16), Concerning the Compatibility of the French Anti-Abuse Rule Regarding Outbound Dividends with the EU Parent-Subsidiary Directive (2011/96) and the Fundamental Freedoms, in European Taxation, October 2018, pag. 471 e segg. In particolare, i membri della Task Force evidenziano come il testo dei nuovi paragrafi 2 e 3 dell’art. 1 della Direttiva madre-figlia lasci ampio spazio all’interpretazione, ponendo le premesse per possibili contrasti tra la Direttiva e le relative norme nazionali di recepimento rispetto alle libertà fondamentali. Nello stesso senso, si veda, AA. VV., EU Report in Seeking anti-avoidance measures of general nature and scope – GAAR and other rules (IFA Cahiers vol 103a, IBFD 2018), pag. 78. In senso contrario, invece, L. De Broe e D. Becker, The General Anti-Abuse Rule of the Anti-Tax Avoidance Directive: An Analysis Against the Wider Perspective of the European Court of Justice’s Case Law on Abuse of Eu Law, in EC tax Review (2017), pag. 133 (a pag. 142). In particolare gli Autori osservano che, sebbene la GAAR rappresenti una misura di armonizzazione minima e, per ciò stesso, non esaustiva, è dubbio se gli Stati membri possano introdurre misure nazionali più rigide. Ove la GAAR venga considerata una misura di armonizzazione esauriente, le norme nazionali di implementazione dovrebbero essere valutate solo alla luce del testo della Direttiva e non della legislazione primaria.
[40] La questione è pure affrontata nella sentenza in commento in cui la Corte precisa che “in una situazione in cui il regime, previsto dalla direttiva 90/435, di esenzione dalla ritenuta alla fonte per i dividendi corrisposti da una società residente in uno Stato membro ad una società residente in un altro Stato membro risulti inapplicabile a fronte dell’accertamento di una frode o di un abuso, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva medesima, non può essere invocata l’applicazione delle libertà sancite dal Trattato FUE al fine di mettere in discussione la normativa del primo Stato membro posta a disciplina della tassazione di detti dividendi“ (punto 123).
[41] A tal riguardo, la Corte nella sentenza C-116/16 al punto 108 afferma che al fine di accertare l’applicabilità dell’esonero in base alla Direttiva madre-figlia sarebbe “irrilevante il fatto che taluni beneficiari effettivi dei dividendi versati dalla società interposta siano fiscalmente residenti in uno Stato terzo che abbia concluso con lo Stato membro d’origine una convenzione volta ad evitare le doppie imposizioni” che, al pari della Direttiva, esonera i suddetti dividendi da imposizione alla fonte; e ciò in quanto “l’esistenza di una convenzione di tal genere non può, di per sé, escludere un abuso”. Poco più avanti, al punto 110, in contraddizione con l’affermazione appena sopra riportata, la stessa Corte, tuttavia, osserva che “non può essere nemmeno escluso, a fronte di una situazione in cui i dividendi sarebbero stati esentati in caso di versamento diretto alla società con sede in uno Stato terzo, che la finalità della struttura di gruppo sia estranea a qualsiasi abuso. In tal caso, non potrà essere contestato al gruppo di aver optato per una struttura siffatta piuttosto che per un versamento diretto dei dividendi alla società medesima”. Come già osservato in altra sede, nel tentativo di conciliare le due (fra loro contraddittorie) affermazioni, una possibile lettura che ci sentiamo di avanzare è quella secondo cui il fatto che solo taluni dei beneficiari ultimi dei dividendi avrebbero potuto comunque beneficiare dell’esonero da ritenuta ai sensi di una Convenzione tra lo Stato della fonte ed il rispettivo Stato di residenza non sarebbe da solo sufficiente ad escludere la sussistenza di un abuso, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria – in presenza di altri indici di artificiosità della struttura – potrebbe sollevare una contestazione fondata sull’abuso. Tuttavia, nell’ambito della ripartizione dell’onere della prova secondo cui, in linea di principio, spetta al contribuente dimostrare di soddisfare le condizioni oggettive previste per beneficiare della Direttiva , laddove questi fosse in grado di dimostrare che tutti i dividendi avrebbero potuto beneficiare dell’esonero in caso di versamento diretto a favore di un soggetto residente in uno Stato terzo che abbia stipulato una Convenzione con lo Stato della fonte non dovrebbe residuare alcun margine per possibili contestazioni fondate sul principio dell’abuso, stante l’assenza di qualsiasi risparmio d’imposta ; e ciò senza che il contribuente debba ulteriormente addurre altre ragioni economiche o commerciali che giustifichino la costituzione della holding intermedia.
[42] Si pensi, ad esempio, al caso di una società residente la quale distribuisca dividendi a favore di una holding europea la quale a sua volta ridistribuisca i suddetti dividendi ad un fondo localizzato in Italia. In questo caso, seguendo l’impostazione sostenuta nel testo, dovrebbe essere esclusa qualsiasi forma di abuso (e, quindi, dovrebbe essere confermata l’applicabilità dell’esonero ai sensi della Direttiva madre-figlia) posto che i suddetti dividendi non avrebbero subito alcun prelievo nell’ipotesi in cui fossero stati distribuiti direttamente a favore del fondo italiano, con la conseguenza che i benefici della Direttiva madre-figlia non dovrebbero essere negati, a prescindere dalla verifica della “sostanza” della holding intermedia.
[43] Si veda, per tutte, sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato/Simmenthal, punto 24.
[44] Si veda il punto 122 della sentenza sulle Cause riunite C-116/16 e C-117/16.