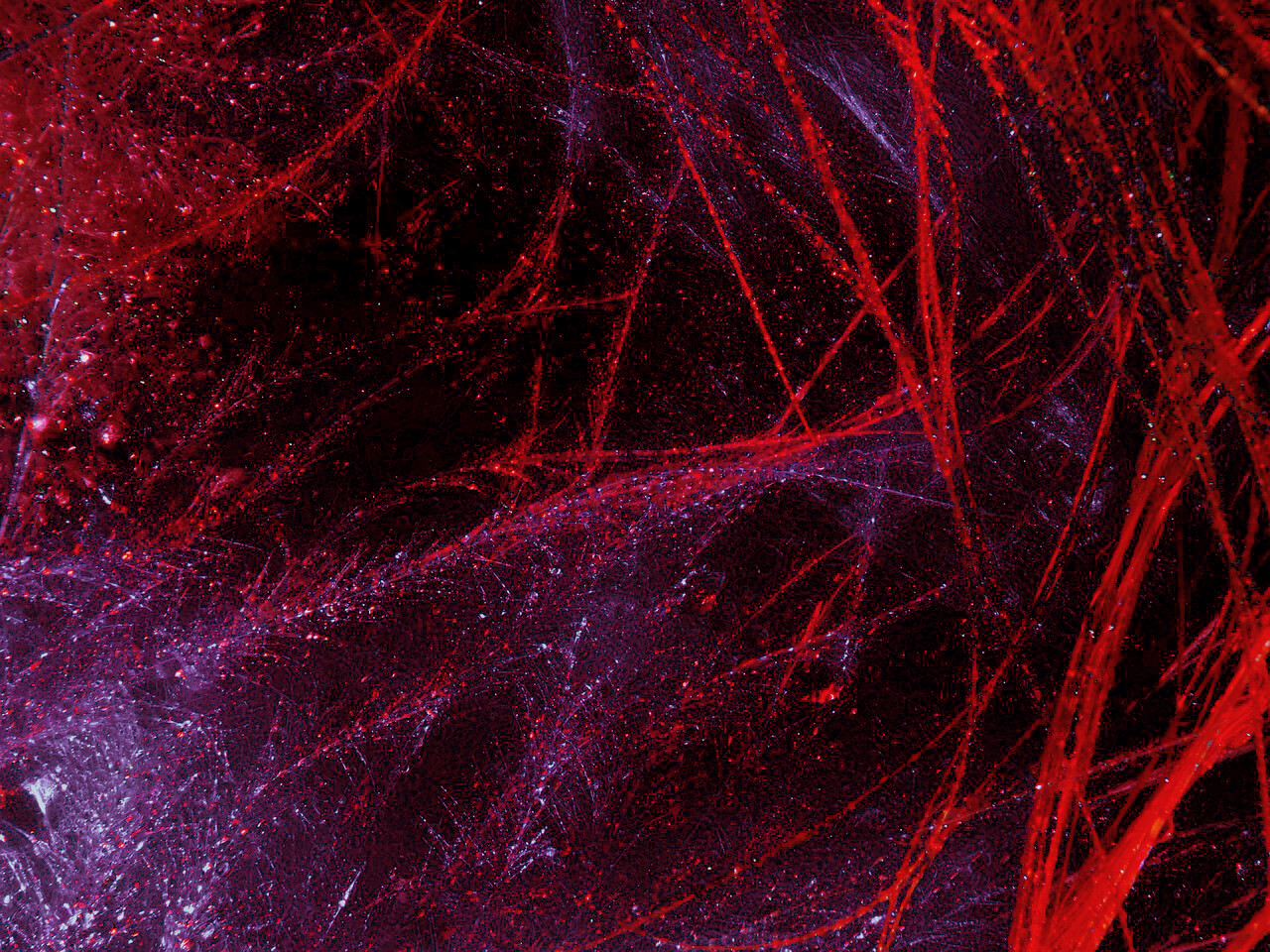La massima «il fine giustifica i mezzi», con la quale si usa indicare l’atteggiamento pratico del machiavellismo e del gesuitismo (benché non compaia, almeno in questa forma, né negli scritti di Machiavelli né in quelli dei gesuiti), indica un metodo inapplicabile nella democrazia costituzionale, in quanto incompatibile con i suoi paradigmi fondanti. In tale contesto, infatti, il fine di per sé non è sufficiente a giustificare i mezzi poiché la necessità di salvaguardare la pluralità dei fini da perseguirsi (in quanto previsti in Costituzione) e di quelli, comunque, perseguibili (in quanto non incompatibili con essa e con le leggi vigenti) esclude che si possa consentire l’uso di ogni strumento utile a raggiungere lo scopo verso cui si tende. Il pluralismo che connota tale forma di Stato impone un’attenta e costante vigilanza sulla natura dei mezzi e sul rapporto tra questi e i fini perseguiti nell’esercizio delle pubbliche funzioni.
I mezzi, oltre a essere leciti, devono risultare proporzionati, tali da non compromettere del tutto altri beni costituzionali che potrebbero essere danneggiati o sacrificati irrimediabilmente. È questa un’esigenza di cui tutti i titolari di pubbliche funzioni devono sempre tenere conto, anche in una fase di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo.
La salvaguardia della salute come «interesse della collettività» (art. 32, co. 1, Cost.) può ammettere restrizioni anche incisive in situazioni eccezionali, ma non può giustificare limitazioni abnormi dei diritti fondamentali, insostenibili per il sistema costituzionale. Per questo, tutte le misure restrittive delle libertà finora adottate (e quelle che ancora potrebbero intervenire) per contenere la diffusione del coronavirus non possono ritenersi esentate dal sindacato degli organi giudiziari competenti, dovendosi poterne vagliare la proporzionalità, l’adeguatezza e la ragionevolezza. Il fine di contrastare la pandemia, infatti, non può essere perseguito sacrificando in misura intollerabile o in modo definitivo la stessa salute di molti altri cittadini affetti da patologie che le misure restrittive della libertà di circolazione rischiano di aggravare, o ancora altri beni costituzionali come il diritto al lavoro, la libertà di religione, le libertà economiche ecc.
Non deve suscitare scandalo, dunque, la decisione del Giudice di pace di Frosinone che, alla fine di luglio, ha annullato una sanzione comminata a un padre e a una figlia, trovati fuori casa durante il lockdown perché erano andati a fare rifornimento d’acqua presso un distributore a scheda (sent. n. 516/2020). E, tuttavia, se può apparire condivisibile lo scopo (dato il carattere abnorme del provvedimento fatto oggetto di censura nel giudizio definito con la pronuncia che qui si commenta), a non convincere è il percorso argomentativo seguito dal giudice, che forse avrebbe potuto scegliere una diversa strada per giungere al medesimo risultato. Anche per gli organi giurisdizionali, infatti, il fine non giustifica i mezzi.
La sentenza dichiara l’illegittimità (ovviamente con efficacia limitata al caso) della deliberazione dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, nonché di tutti gli atti amministrativi conseguenti (compreso il d.P.C.m. richiamato dal verbale opposto), in ragione del fatto che nessuna fonte costituzionale o legislativa attribuirebbe «il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario».
Il ragionamento sviluppato nella motivazione della pronuncia è il seguente: l’art. 7, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile) definisce «emergenze di rilievo nazionale» quelle «connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo»; con la deliberazione del 31 gennaio, il Consiglio dei ministri ha dichiarato, in base alla suddetta disposizione e all’art. 24, co. 1, del d.lgs. n. 1/2018, lo stato di emergenza «in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; pertanto, dal momento che né il Codice di protezione civile né la Costituzione riconoscerebbero al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo specifico tipo di «stato di emergenza per rischio sanitario», il provvedimento del Governo risulterebbe illegittimo per carenza dei necessari presupposti legislativi. Il Giudice di pace aggiunge, poi, di ritenere costituzionalmente illegittima l’adozione con d.P.C.m. di norme generali e astratte, limitative di diritti fondamentali, reputando insufficiente la copertura fornita a tali provvedimenti dai decreti-legge approvati dal Governo (n. 6/2020 e n. 19/2020). Le misure introdotte dai d.P.C.m. alla base della sanzione oggetto del giudizio, infine, sarebbero illegittime anche perché, «stabilendo un divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni», non riguarderebbero la libertà di circolazione, ma configurerebbero un «obbligo di permanenza domiciliare», misura restrittiva della libertà personale che richiederebbe, in base all’art. 13 Cost., l’atto motivato dell’autorità giudiziaria. Un simile obbligo, stabilito per legge nei confronti di tutti i cittadini, sarebbe, dunque, contrario a Costituzione.
L’intera argomentazione poggia su basi piuttosto fragili.
Discutibile e non pertinente appare la precisazione relativa alla deliberazione dello stato di emergenza. Discutibile perché, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di pace, non sembra dubbio che nella formula «eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo», impiegata nell’art. 7, co. 1, lett. c) del Codice della protezione civile, possano farsi rientrare anche le epidemie e i connessi rischi sanitari di cui parla la deliberazione del 31 gennaio. Il termine “calamità” (derivato dal latino calamitas, che vuol dire disgrazia, sciagura) indica, infatti, una «grave sventura, che colpisce molte persone o un’intera comunità, implicando provvedimenti speciali» (così G. Devoto, G.C. Oli, L. Sirianni, M. Trifone, Il vocabolario dell’italiano contemporaneo, Le Monnier, Milano, 2017, 331; ma si veda anche la relativa voce in www.treccani.it, nella quale, tra gli esempi di «pubbliche calamità», si indicano espressamente le pestilenze). A fugare ogni dubbio è, comunque, la definizione legislativa che si rinviene nell’art. 1 della legge n. 996/1970 (Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione civile), ove si prevede che «s’intende per calamità naturale o catastrofe l’insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari». Una definizione che certamente comprende anche le epidemie.
La precisazione, però, risulta anche incongrua, posto che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri oggetto del giudizio non trovavano il proprio presupposto nella deliberazione dello stato d’emergenza e, dunque, il problema non era se il Codice della protezione civile fosse fonte idonea a dare loro un’adeguata copertura legislativa. La deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, in base a quanto previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 1/2018, non consente, infatti, l’adozione di provvedimenti del genere, bensì di ordinanze della protezione civile.
La base legale dei provvedimenti contestati dinanzi al Giudice di pace di Frosinone era fornita, invece, dai decreti-legge n. 6 e n. 19/2020. L’idoneità di tali atti a coprire la riserva di legge posta a presidio delle libertà limitate dalle misure di contenimento del contagio – questione liquidata in modo piuttosto sbrigativo nella pronuncia – è, invece, tema ben più complesso.
Occorre premettere, innanzitutto, che la scelta di gestire, sul piano normativo, l’emergenza principalmente attraverso lo strumento del d.P.C.m. è dipesa dall’esigenza di adottare una tecnica di regolazione agile, che consentisse un accentramento dell’attività normativa adeguato al continuo mutare del contesto. I mezzi a disposizione sulla base della disciplina vigente – le ordinanze della protezione civile, alle quali si è già fatto cenno, e le ordinanze contingibili e urgenti previste dall’art. 32 della legge sul Servizio sanitario nazionale (l. n. 833 del 1978) – non sono apparsi sufficienti allo scopo. In astratto, non sembra che tale tecnica sia incompatibile con il dettato costituzionale, come pure afferma il Giudice di pace di Frosinone (sul punto sia consentito rinviare al mio Il Re del Piccolo Principe ai tempi del Coronavirus. Qualche riflessione su ordine istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di emergenza, in Diritti regionali, Forum, La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed Enti locali, 1/2020, 518 ss.).
Semmai carenze vistose si sono riscontrate nella cattiva formulazione degli stessi decreti-legge, il primo dei quali, in particolare, prevedeva un’elencazione non tassativa delle misure adottabili e autorizzava il Presidente del Consiglio ad assumere non meglio precisate «ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza». Il decreto-legge n. 19 ha, poi, parzialmente corretto i difetti del precedente decreto-legge n. 6, specificando, tra l’altro, che le misure espressamente indicate (nell’art. 1, co. 2) possono essere adottate, con d.P.C.m., «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso» (art. 2, co. 1).
Lo stesso decreto-legge n. 19, peraltro, ha fatto salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6, nonché le ordinanze contingibili e urgenti approvate ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978. E ancora ha stabilito che continuassero ad applicarsi le misure già adottate con i precedenti d.P.C.m. (art. 2, co. 3).
Nel complesso, la tecnica adottata non appare dissimile dal potere di ordinanza extra ordinem esercitato da Regioni e Comuni, ritenuto non illegittimo dalla giurisprudenza purché esercitato entro certi limiti: sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile per la pubblica incolumità, non affrontabile con i mezzi ordinari; provvisorietà e temporaneità degli effetti; proporzionalità dell’intervento; adeguata motivazione; conformità del provvedimento ai principi dell’ordinamento, ecc. (Corte cost., n. 8/1956, n. 26/1961, n. 4/1977; Cons. St., sev. V, n. 774/2017; in dottrina, per tutti, E. Raffiotta, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da Coronavirus, in BioLaw Journal, Special Issue 1/2020, 95 ss. e, più ampiamente, Id., Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bononia University Press, Bologna, 2019).
Nella decisione del Giudice di pace si afferma, in astratto, che la tecnica normativa adottata sarebbe di per sé illegittima, senza indagare sull’effettiva capacità della disciplina contenuta nei decreti-legge di limitare l’ambito d’intervento del Presidente del Consiglio, in modo tale da rispettare il principio costituzionale di legalità.
Quanto, infine, all’ultimo argomento, relativo all’incidenza delle misure oggetto di contestazione sulla libertà personale, pur dovendosi riconoscere che, in dottrina e in giurisprudenza, si riscontrano incertezze sulla linea di confine tra libertà di circolazione e libertà personale, ad esempio nel campo delle misure di detenzione (in tema si veda ora G. D’Amico, La libertà “capovolta”. Circolazione e soggiorno nello Stato costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, 37 ss.), le limitazioni previste dal d.P.C.m. del 9 marzo 2020 non sono certo assimilabili – per natura giuridica, effetti e sanzioni – a un obbligo di permanenza domiciliare, come si afferma nella decisione. Si applicano, pertanto, le garanzie dell’art. 16 Cost. riguardo alla libertà di circolazione, che non contemplano l’atto motivato dell’autorità giudiziaria.
La carente motivazione della pronuncia non deve rafforzare l’idea che la gestione dell’emergenza sanitaria che stiamo ancora affrontando – un’esperienza inedita per gravità e durata (almeno nella storia repubblicana) – sia sottratta al controllo degli organi di garanzia. Da questi ultimi, tuttavia, ci si attende un sindacato i cui esiti siano supportati da null’altro che da motivazioni congrue e sufficienti, poiché il fine non è mai sufficiente, da solo, a giustificare i mezzi.