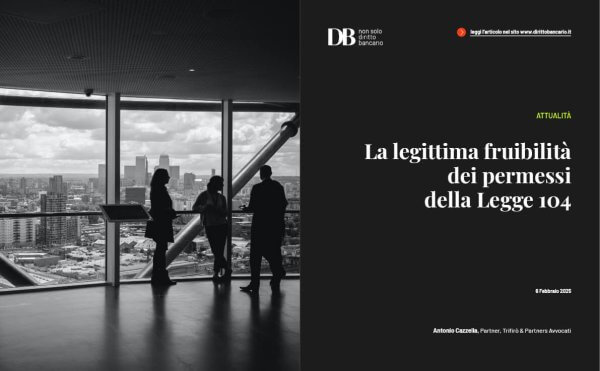Il presente contributo affronta il tema dalla legittima fruibilità dei permessi della legge 104 /1992 disciplinati all’art. 33 secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
1. La finalità della legge 104/1992 ed i permessi disciplinati dall’art. 33
La legge n. 104/1992 è finalizzata ad assicurare un adeguato sostegno sia ai disabili, sia ai familiari che, spesso, sono chiamati a prendersi cura di loro.
Tra i temi affrontati dalla giurisprudenza vi è quello inerente le modalità di fruizione di alcuni benefici concessi ai familiari del lavoratore disabile e, più precisamente, quello relativo alle condizioni per fruire (legittimamente) di un permesso retribuito di tre giorni mensili per assistere il disabile in situazione di gravità, che non sia ricoverato a tempo pieno (art. 33).
Anche se il presente contributo non esaminerà il quadro di tutti i requisiti necessari per fruire di tali permessi, è tuttavia opportuno ricordare alcuni importanti interventi – successivi alla legge 104/1992 – attuati nel tempo, tra cui, ad esempio, la legge n. 76/2016 (c.d. “legge Cirinnà”) e la sentenza n. 213/2016 della Corte Costituzionale (che hanno esteso i benefici alla parte dell’unione civile nonchè al convivente del disabile), senza dimenticare quelli, più recenti, attuati dal d.lgs. n. 105/2022 e dal d.lgs. n. 62/2024, che comunque non hanno mutato l’assetto dei principi giurisprudenziali qui illustrati.
2. La giurisprudenza di legittimità sui permessi della Legge 104
Con specifico riferimento al tema in esame, ovvero le modalità per fruire legittimamente dei permessi ex art. 33 Legge 104, si osserva che la norma non individua, in concreto, le modalità dell’assistenza (ad esempio, in termini infermieristici e/o di accompagnamento: Cass. 24 agosto 2022, n. 25290) che possa o debba essere riservata alla persona con disabilità – oggetto di valutazione nel caso di accertamento giudiziale – in quanto la ratio della legge è quella di assicurare “in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile” (in tal senso, anche recentemente, Cass. 10 ottobre 2024, n. 26417).
Ciò non significa, tuttavia, che tale diritto possa essere esercitato senza alcuna limitazione: infatti, è configurabile un abuso del medesimo, sanzionabile sul piano disciplinare anche con il licenziamento per giusta causa, quando il lavoratore utilizzi un permesso per fini differenti dall’assistenza, circostanza che può desumersi anche dal tempo dedicato alle attività assistenziali.
La giurisprudenza ha comunque chiarito che i permessi della Legge 104 sono individuati quali permessi giornalieri su base mensile (non su base oraria o cronometrica), con la conseguenza che “l’assistenza del familiare può realizzarsi in forme non specificate” (Cass. n. 26417/2024, cit.).
In conclusione, il lavoratore può svolgere attività collegate agli interessi del disabile (ad esempio, fare la spesa o incontrare professionisti), ma il tempo impiegato per assistere il disabile non può essere irrisorio, anche perchè il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore, e dalla coscienza sociale, come meritevoli di superiore tutela (Cass. 14 maggio 2024, n. 13274).
Pertanto, posto che il permesso comporta un onere organizzativo per il datore di lavoro nonchè un costo per l’ente assicurativo, giustificato solo dalla necessità di assistere il disabile, se il nesso tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza stessa manca, il lavoratore viola i principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, realizzando un uso improprio del diritto (tra le tante, Cass. 9 maggio 2024, n. 12679).
E’ stato infatti sottolineato il disvalore sociale della condotta del lavoratore che usufruisce, anche solo in parte, di permessi per l’assistenza al disabile al fine di soddisfare proprie esigenze personali scaricando il costo di tali esigenze sull’intera collettività, posto che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro (che viene poi sollevato dall’ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi), il quale deve ricorrere ad una diversa organizzazione del lavoro per far fronte all’assenza, con possibili conseguenze sui colleghi del lavoratore assente, che devono eventualmente sostituirlo, anche ove ciò comporti una maggiore penosità della prestazione lavorativa (Cass. 13 marzo 2023, n. 7301).
Ciò che quindi rileva, ai fini disciplinari, è verificare la gravità della violazione dei doveri di correttezza e di buona fede da parte del lavoratore, a prescindere dalla possibilità di definire tale comportamento come “abuso”, nozione peraltro integrata “tra i principi della Carta dei diritti dell’unione Europea (art. 54), dimostrandosi così il suo crescente rilievo nella giurisprudenza di Europea” (Cass. n. 12679/2024, cit.).
Per completezza, si soggiunge che non può rilevare, al fine di escludere l’illegittimità della condotta ai fini disciplinari, la “gratuità” di un’eventuale prestazione lavorativa (presso terzi) svolta durante l’assenza per fruire dei permessi, essendo agevolmente desumibile dalla ratio della legge l’uso illegittimo e/o distorto del beneficio nell’ipotesi di svolgimento (continuativo) di un’attività gratuita che non sia funzionale agli interessi del disabile.
3. Alcuni temi processuali
E’ pacifico che spetta al Giudice di merito verificare se il permesso sia stato fruito dal lavoratore in difformità dalle modalità richieste dalla natura e dalle finalità per cui è consentito di assentarsi dal lavoro (Cass. n. 26417/2024, cit.), dovendo precisarsi che il “grado di sviamento” della condotta rispetto alla finalità per la quale il permesso viene concesso è una valutazione insindacabile in sede di legittimità (come evidenziato anche da Cass. n. 12679/2024, cit.), essendo pacificamente preclusa, in tale sede, una ricostruzione della vicenda fattuale.
Sotto un ulteriore profilo, vale la pena di evidenziare, sempre nell’ottica di un inammissibile riesame dei fatti in sede di legittimità, che la valutazione del Giudice di merito sulla proporzionalità della sanzione disciplinare inflitta al dipendente – che implica, inevitabilmente, un apprezzamento dei fatti storici che hanno dato origine alla controversia – è sindacabile soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere articolata sulla base di espressioni-argomenti tra loro inconciliabili o, comunque, manifestamente ed obiettivamente incomprensibili; in altri termini, per censurare fondatamente la valutazione sulla proporzionalità della condotta addebitata, frutto di selezione e di valutazione di una pluralità di elementi, il lavoratore soccombente non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione degli stessi, ma dimostrare che quello eventualmente trascurato avrebbe sicuramente condotto ad una differente decisione (Cass. n. 6468/2024, cit.).
4. Considerazioni conclusive. Le più recenti sentenze della Corte di Cassazione
Alla luce di quanto illustrato, per valutare la legittima fruibilità dei permessi della Legge 104, è necessario considerare le concrete modalità dell’assistenza prestata in favore del disabile.
Il tema è attuale, considerato che, ancora recentemente, la Suprema Corte – operando una sintesi di principi già affermati – ha affermato che, per configurare un abuso del diritto di utilizzare i permessi per l’assistenza al familiare disabile, non si possono valutare solo gli aspetti quantitativi (ovvero, il tempo dedicato), ma anche il contesto qualitativo e le attività complementari all’assistenza (Cass. 17 gennaio 2025, n. 1227).
E’ stata, inoltre, ribadita la legittimità dei controlli effettuati mediante un’agenzia investigativa, trattandosi di controlli che non riguardano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, ferma restando la “chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall’obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile” (Cass. 30 gennaio 2025, n. 2157).
Nella fattispecie, il lavoratore era stato licenziato in quanto, all’esito delle indagini svolte da un’agenzia investigativa, era emerso che, in varie giornate, aveva utilizzato la metà delle ore di permesso richieste per andare in giro con la bicicletta da corsa (dopo aver indossato un abbigliamento sportivo al rientro dal lavoro).
A tal riguardo, richiamando le valutazioni della Corte territoriale, è stato evidenziato che tale illegittimo comportamento era caratterizzato da una “preordinata reiterazione e sistematicità della condotta, desunta dal numero e dalla frequenza degli episodi” (Cass. n. 2157/2025, cit.).