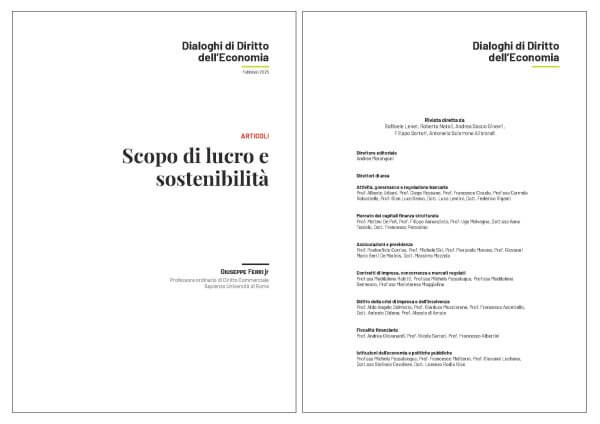SOMMARIO[*]: Nell’ordinamento italiano la sostenibilità economica dell’impresa rappresenta un valore prevalente rispetto alla sostenibilità ecologica o sociale, la quale viene considerata, a seconda dei casi, sia come un rischio, del deve essere informato quale il mercato, sia come un’opportunità, cioè come un vero e proprio strumento di concorrenza, del quale allora evitare gli abusi, sia come oggetto di tutela in quanto tale: in particolare, sono stati previsti una serie di modelli speciali di società diretti ad assegnare specifica rilevanza, in termini tra loro diversi, ad esigenze di sostenibilità non economica.
ABSTRACT: In the Italian legal system, the economic sustainability of a company represents a prevailing value over ecological or social sustainability. Sustainability, in its threefold meaning – environmental, social, and governance – is considered, depending on the case, either as a risk, about which the market must be informed, or as an opportunity, that is, a real instrument of competition, the abuse of which must be prevented. Alternatively, it may be regarded as an object of protection in itself. In particular, a series of special corporate models have been introduced to assign specific relevance, in different ways, to non-economic sustainability requirements.
1. Premessa
Il tema oggetto della relazione si presenta come un’equazione a due incognite: se è nota, infatti, la pluralità di significati che l’espressione sostenibilità è venuta assumendo, non meno varie sono non solo le accezioni nelle quali si parla di scopo di lucro, a partire da quelle evocate dalla distinzione tra lucro oggettivo e lucro soggettivo, ma anche, e prima ancora, le forme di rilevanza che esso presenta, a seconda, in particolare, che si abbia riguardo all’impresa o, rispettivamente, alla società.
Se, infatti, in ordine alla prima si tende ad escludere, o comunque a contenere, nei termini che si diranno, l’essenzialità dello scopo lucrativo, al contrario lo scopo di dividere gli utili, in particolare quelli derivanti dall’esercizio di un’attività economica, e dunque di esercitare un’attività in grado di generarli, ricorre nella stessa definizione legislativa di società offerta dall’ordinamento italiano: il quale, sotto lo specifico profilo dello scopo di lucro, si avvicina a quello francese, distanziandosi tanto da quello tedesco, che si riferisce genericamente ad uno scopo comune, quanto da quello nordamericano, che assegna al termine Corporation un significato ben più ampio, sostanzialmente corrispondente a quello di persona giuridica[1].
A sua volta, il diverso ruolo assunto dallo scopo di lucro in relazione a ciascuna di tali figure si comprende alla luce della circostanza che l’impresa indica un fenomeno produttivo di ricchezza, oggettivamente considerato e destinato ad operare indefinitamente nel tempo, che l’ordinamento regola al fine di accordare rilevanza alla pluralità degli interessi da essa coinvolti: solo uno dei quali è rappresentato da quello, di regola (ma non necessariamente) speculativo, dell’imprenditore; la società, al contrario, è essenzialmente uno strumento di investimento, nel quale prende forma un’operazione, da un lato, funzionalmente lucrativa, nell’ambito della quale l’esercizio dell’impresa assume un ruolo solo strumentale, non rappresentando altro che un mezzo, quello ampiamente più diffuso, di produzione del lucro destinato ai soci: e, dall’altro, strutturalmente a termine, risultando destinata a concludersi con il momento del disinvestimento, almeno individuale: come dimostra il fatto che tutte le volte in cui i soci non hanno fissato il termine finale della società, vale a dire dell’investimento collettivo, l’ordinamento consente comunque al singolo socio il diritto di recedere, cioè appunto di disinvestire individualmente, in qualsiasi tempo.
Tutto ciò preclude allora in radice qualsiasi tentativo di svolgere un discorso unitario in ordine allo scopo di lucro, imponendo piuttosto di mantenere tra loro nettamente distinte la disciplina dell’impresa e, rispettivamente, quella della società: sempre che si intenda mantenere l’analisi su un piano normativo, cioè strettamente aderente al diritto positivo, in particolare a quello italiano attuale, senza spostarsi su un piano politico, se non anche ideologico, come invece accade spesso proprio in materia di sostenibilità, in ordine alla quale talora si registra la tendenza a passare, indifferentemente, e non sempre consapevolmente, dall’una all’altra dimensione.
2. Il dibattito.
In realtà, l’esigenza, eminentemente tecnica, e comunque circoscritta al nostro ordinamento, di tenere conto del diverso ruolo che lo scopo di lucro riveste nella disciplina dell’impresa e, rispettivamente, in quella della società di solito non viene minimamente avvertita, assistendosi ad una continua sovrapposizione di piani: come dimostra, plasticamente, di là dall’abitudine, diffusissima, ad affrontare il problema del rapporto tra scopo di lucro e sostenibilità riferendosi pressoché esclusivamente all’impresa organizzata in forma societaria, assai eloquente risultando la frequente utilizzazione dell’espressione, sincretica, di “impresa azionaria”, che ricorre fin dal titolo di alcuni tra i più noti lavori monografici dedicati all’argomento[2], la tendenza per un verso, ad evocare, ai fini in esame, il tema dell’interesse, ancora una volta, sociale, e dunque la tradizionale questione se si tratti di una formula che esprime, sinteticamente, l’interesse comune dei soci, gli shareholders, o se in esso rientrino anche interessi “altri”, ai primi in via di principio contrapposti, e, segnatamente, quelli di cui sono “portatori” soggetti estranei alla società, gli stakeholders[3]; per altro verso, e soprattutto, quella ad impostare il problema in esame intorno al rapporto tra soci e amministratori[4]: interrogandosi cioè se questi ultimi siano tenuti a perseguire, o meglio a massimizzare, l’interesse lucrativo dei primi, anche a scapito della realizzazione di esigenze ascrivibili ad istanze di sostenibilità, o, tutto al contrario, a realizzare siffatte esigenze anche a costo di penalizzare la produzione di lucro da destinare ai soci o, infine, a bilanciare in qualche modo tra loro siffatti interessi.
Le cause di un approccio siffatto sembrano in particolare riconducibili a due ordini di ragioni, l’una specifica della materia della sostenibilità, l’altra più generale: si allude, da un lato, alla vocazione internazionale che, fin dall’origine, ha caratterizzato il dibattito dottrinale e la produzione normativa relativa ai temi della sostenibilità (e la conseguente, ed inevitabile, prevalenza di un approccio in definitiva politico), e segnatamente alla circostanza che la questione è sorta, e si è sviluppata, in sistemi, a partire da quelli anglosassoni, nei quali nemmeno ha senso distinguere, come nel nostro, tra impresa e società, nei quali cioè i problemi dell’impresa, e segnatamente della grande impresa, sono riferiti alla Corporation, come dimostra la fortunata espressione Corporate Social Responsibility, correttamente tradotta come responsabilità sociale dell’impresa, non della società; e, dall’altro, alla convinzione che, anche nel nostro sistema, la società rappresenti unicamente, o comunque essenzialmente, una forma di esercizio dell’impresa, se non addirittura un tipo di imprenditore: una convinzione, questa, che già si coglieva con chiarezza dalle riflessioni sull’interesse sociale, che proprio l’emersione delle tematiche legate alla sostenibilità hanno riportato all’attenzione[5], seppure nell’ambito di discussioni relative a quello che viene chiamato, a seconda dei casi, scopo, finalità e, con terminologia importata da altri sistemi, purpose o anche ragion d’essere. Non vuole, ovviamente, negarsi che la società, di regola, venga utilizzata come forma di organizzazione dello svolgimento e del finanziamento dell’impresa, e nemmeno, come si vedrà, che la legge, in taluni casi, la disciplini, e prima ancora la consideri, proprio in questa veste: ma solo precisare che la funzione essenziale, e sistematicamente prevalente, della società è, e resta, quella di strumento di investimento.
Ancor più delle cause, meritano di essere sottolineati gli effetti dell’approccio in esame, il quale, riferendo il problema della rilevanza della sostenibilità alla sola impresa organizzata in forma societaria, lo esaurisce sul piano dei rapporti tra soci e amministratori, e dunque più concretamente su quello dei doveri e della responsabilità di questi ultimi, con l’esito di renderlo, ma solo apparentemente, più lineare: trattandosi, in definitiva, di individuare quale sia il comportamento dovuto dagli amministratori e, parallelamente, in quali casi costoro possano essere chiamati a rispondere nei confronti dei soci per non averlo tenuto; assai più complesso, come dimostrano le discussioni intorno all’art. 2086, comma 2, c.c. e all’art. 3 c.c.i.i., è invece stabilire, a fronte di disposizioni che si limitano a prevedere, genericamente, determinati doveri dell’imprenditore, nei confronti di chi costui possa dirsi responsabile della loro violazione: e prima ancora, in mancanza dell’espressa previsione di sanzioni, se una sua responsabilità possa effettivamente configurarsi o se addirittura possa ancora parlarsi di veri e propri doveri.
La semplificazione, tuttavia, è, come si accennava, solo apparente, dal momento che siffatta sovrapposizione di piani finisce, a ben vedere, non tanto e non solo per ridimensionare sensibilmente la portata, e dunque l’utilità stessa, del dibattito, quanto piuttosto, e soprattutto, per pregiudicarne inevitabilmente gli esiti.
Per un verso, infatti, mentre quello della rilevanza da accordare ad istanze di sostenibilità è un problema generale, che si pone cioè nei confronti di qualsiasi impresa, indipendentemente dalla forma in concreto assunta[6], le soluzioni ad esso offerte, e proprio in quanto ricavate dalla ricostruzione del rapporto, gestorio, tra titolare dell’interesse e soggetto tenuto a realizzarlo[7], risultano particolari, e dunque parziali, in quanto adeguate unicamente alle imprese, come appunto quelle societarie, esercitate nell’interesse altrui: non anche a quelle esercitate nel proprio interesse, a partire da quella organizzata in forma individuale, in cui un rapporto siffatto risulta, e per definizione, assente.
Per altro verso, una volta circoscritta l’attenzione all’impresa societaria, non soltanto il rapporto tra l’interesse, tipicamente lucrativo, dei soci e le esigenze di sostenibilità, di cui sono portatori altri soggetti, finisce per assumere un carattere per definizione conflittuale, ma tale conflitto, almeno stando al diritto positivo italiano, non può che risolversi nel senso di accordare prevalenza al primo, e proprio per la centralità che, nel nostro ordinamento, lo scopo di lucro assume tanto nella “fattispecie” societaria, quanto, e soprattutto, nella relativa “disciplina”: tanto che, quando si è inteso assegnare rilevanza, nell’ambito della società, ad esigenze riconducibili al tema della sostenibilità, si è reso necessario introdurre, attraverso espresse disposizioni normative, significative alterazioni, sotto l’uno o l’altro profilo, dell’ordinaria disciplina societaria[8], e cioè configurare modelli speciali di società.
Tutto ciò induce, allora, non soltanto a distinguere a seconda che si tratti della disciplina dell’impresa o, rispettivamente, della società, ma, riarticolando, e arricchendo, il titolo della relazione, a soffermarsi, partitamente, sul rapporto tra impresa e sostenibilità, da un lato, e tra società e scopo di lucro, dall’altro, riservando maggiore attenzione al primo di tali profili, quello di portata più generale.
3. Impresa e sostenibilità.
Il ruolo ricoperto dalla sostenibilità nell’ambito dell’impresa e della sua disciplina presenta atteggiamenti tra loro radicalmente diversi a seconda che si abbia riguardo alla sostenibilità economica, che viene in considerazione anche sul piano della fattispecie, o, rispettivamente, a quella ambientale e sociale, che invece si presta ad assumere rilevanza solo su quello della disciplina.
Premesso che, in relazione all’impresa, cioè, come detto, ad un fenomeno produttivo oggettivamente considerato, lo scopo di lucro non può certo intendersi in termini di movente soggettivo dell’imprenditore, quanto piuttosto in quelli di modalità oggettiva dell’attività, o, meglio, di carattere oggettivo della produzione e della sua organizzazione, può notarsi, quanto in particolare alla fattispecie, come sia diffusa la tendenza a negare che uno scopo siffatto rappresenti un elemento essenziale della nozione di impresa, e segnatamente di quel suo profilo che si è soliti indicare in termini di economicità, ritenendosi invece che la legge si limiti a richiedere l’adozione di un metodo programmaticamente volto al pareggio dei costi[9]: metodo che, si noti, garantisce anch’esso l’idoneità dell’organismo a produrre ricchezza in senso oggettivo, in misura pari al valore che i fattori della produzione acquistano all’esito del processo produttivo, tanto che pure a tal proposito si è parlato di scopo di lucro oggettivo, a sua volta distinto dall’intento speculativo[10].
In questa sede, tuttavia, a venire in considerazione non è tanto il problema se l’adozione di un metodo siffatto sia o meno sufficiente a qualificare un’attività produttiva in termini di impresa, quanto piuttosto la circostanza, indiscussa, che a tal fine essa risulta comunque necessaria: e che dunque un’attività produttiva svolta secondo modalità tali da non garantire, strutturalmente, e dunque indefinitamente, almeno la copertura dei costi con i ricavi non può qualificarsi, per ciò solo, in termini di impresa, nemmeno, deve anticiparsi, in quelli di impresa sociale.
Intesa in tale accezione, tuttavia, l’economicità non rappresenta altro, a ben vedere, che un’espressione, più antiquata, per designare quella che, attualmente, si è soliti chiamare sostenibilità economica: con la conseguenza che solo le produzioni organizzate in modo economicamente sostenibile si prestano ad essere qualificate in termini di impresa, e che dunque l’impresa o è programmaticamente sostenibile, in senso economico, o non è (impresa).
Ad assumere a questi fini rilevanza, è bene ricordarlo, non è il fatto che l’attività rispetti, effettivamente, il pareggio dei costi, e dunque risulti in concreto economicamente sostenibile, quanto piuttosto, e soltanto, che essa sia esercitata, e prima ancora organizzata, sulla base di un criterio in grado di assicurare, in astratto, tale risultato: risultato che allora ben potrebbe, poi, non essere di fatto raggiunto, come accade tutte le volte in cui l’impresa si riveli incapace di mantenersi sul mercato, vale a dire di continuare ad operarvi per un tempo ragionevole che si è soliti individuare in dodici mesi, in cui, cioè, si verifichi una perdita della sua continuità aziendale.
Anche la continuità aziendale, dunque, al pari dell’economicità, finisce allora per coincidere con la sostenibilità economica: intesa, tuttavia, non già, come la prima, in un’accezione astratta e temporalmente indefinita, ma, questa volta, in termini non solo concreti, ma relativi ad una prospettiva di breve periodo.
Passando al piano della disciplina, può notarsi, limitandosi ovviamente alle regole di diritto positivo, ad esclusione, allora, di quelle rinvenibili in fonti diverse, a partire dal Codice di Corporate Governance[11], come l’ordinamento, pur prendendo in considerazione la continuità aziendale, mostri di regolarne non tanto, su di un piano statico, la sussistenza, quanto piuttosto, in una prospettiva dinamica, da un lato la perdita, e, dall’altro, una volta che questa sia verificata, il recupero, almeno stando a quanto dispone l’art. 2086, comma 2, c.c., nella parte in cui richiede di attivarsi senza indugio per tentare appunto di recuperarla: una regola, questa, testualmente riferita all’“imprenditore che operi in forma collettiva o societaria”, e cioè a tutte le imprese esercitate per conto altrui, ma non all’imprenditore individuale, che, esercitando l’impresa nell’interesse proprio, è libero di gestire come crede un fenomeno, quale la perdita della continuità aziendale, che, in quanto tale, non coinvolge interessi di terzi, a differenza della crisi e dell’insolvenza, che invece incidono su quelli dei creditori.
In quest’ultima eventualità, è appena il caso di notare, trovano applicazione una serie di discipline di carattere generale, si tratti di strumenti di regolazione della crisi o di procedure concorsuali, volte, di regola, e con la parziale eccezione dell’amministrazione straordinaria, a perseguire uno scopo di lucro, per quanto, per dir così, capovolto: consistente cioè nella massimizzazione della soddisfazione dei creditori, un tempo chiamata dividendo fallimentare, e dunque del valore reale dei relativi crediti, al fine di minimizzarne le “perdite”, vale a dire la differenza tra tale valore e quello nominale; ed è proprio questo “lucro” a porsi più spesso in conflitto con istanze di sostenibilità sociale, a partire dalla tutela dei posti di lavoro, e ambientali[12], a loro volta reciprocamente confliggenti: se, sul piano normativo, siffatti conflitti sembrano di regola, in assenza cioè di interventi specifici, doversi risolvere, anche in tal caso, a favore dell’interesse dei creditori, essi, quando coinvolgono imprese di grandi o grandissime dimensioni, sollevano problemi particolarmente gravi che, proprio per ciò, vengono spesso affrontati direttamente sul piano politico.
Tornando all’impresa, essa, e segnatamente quella esercitata per conto altrui, deve essere organizzata in modo non solo di assicurare, in astratto, la sostenibilità economica dell’iniziativa, ma anche di intercettarne, fin dai primi segnali, il venir meno, e, una volta venuta meno, di permetterne il recupero: ma, deve precisarsi, solo qualora, e sempre che i titolari dell’interesse intendano continuare l’iniziativa, e non anche interromperla, dal momento che la libertà di iniziativa economica, della quale la decisione di avviare un’impresa rappresenta un’espressione, sembra implicare, specularmente, anche la scelta di porvi fine in qualunque momento, beninteso nel rispetto delle regole previste dall’ordinamento. In questo senso, allora, per quanto in particolare riguarda l’impresa collettiva, e segnatamente societaria, il dovere, imposto agli amministratori dall’art. 2086, comma 2, c.c., di “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per… il recupero della continuità aziendale” sembra implicare, in primo luogo, quello di consultare i soci, cioè i titolari dell’interesse, al fine di verificare la loro intenzione di perseguire tale obiettivo o, in alternativa, di porre fine all’iniziativa deliberando lo scioglimento della società: non appare pertanto possibile ricavare da tale disposizione l’emersione a livello di giuridica rilevanza di un interesse, superiore rispetto a quello dei soci e da realizzare anche contro la loro volontà, alla continuazione dell’impresa, coerentemente al ruolo strumentale che essa svolge rispetto all’interesse dei soci, oltre che alla mancata previsione di un dovere siffatto in relazione all’impresa individuale.
Nell’ambito dell’impresa e della sua disciplina, insomma, la sostenibilità economica assume un ruolo sistematicamente del tutto centrale, e comunque prevalente rispetto alle altre forme di sostenibilità, siano esse sociali o ambientali: al punto che a queste ultime in tanto appare possibile accordare rilevanza, in quanto, e solo in quanto, esse non pregiudichino la sostenibilità economica dell’impresa.
Passando alla sostenibilità in senso non economico, deve notarsi come la legge mostri di considerarla da punti di vista, ed in termini, tra loro profondamente diversi, se non anche contraddittori: in alcuni casi essa emerge come rischio, del quale allora deve essere informato il mercato, come è a dirsi delle discipline in materia di dichiarazione di sostenibilità[13], che mostrano di considerare i cc.dd. fattori di sostenibilità appunto sotto il profilo del rischio, nella duplice direzione di elementi che possono essere messi a rischio dall’impresa, come era a dirsi in ordine all’originaria dichiarazione non finanziaria[14], o anche che, tutto al contrario, possono rappresentare essi stessi un rischio per l’impresa, secondo la prospettiva seguita, tra l’altro, dalla disciplina della dichiarazione di sostenibilità[15] e, prima ancora, da quella in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari[16].
In altre ipotesi, invece, la sostenibilità, e segnatamente la sostenibilità ecologica, emerge, sempre da un punto di vista normativo, come opportunità, e cioè come un vero e proprio strumento di concorrenza, in quanto dotato (anche se non sempre) di particolare capacità attrattiva, che consente ad una serie soggetti a vario titolo operanti nel mercato, essenzialmente finanziario, sul lato, per dir così, dell’offerta, di valorizzare le preferenze non economiche, e segnatamente quelle ecologiche, di chi si presenta sul medesimo mercato dal lato, invece, della domanda, in veste, a seconda dei casi, di investitore istituzionale o di risparmiatore: trattandosi allora di evitarne utilizzazioni strumentali, il c.d. greenwashing, e dunque di assicurare, per utilizzare il linguaggio dei segni distintivi, la “verità”, o comunque la “non decettività” delle “informazioni” trasmesse al mercato, al fine anche in tal caso di tutelare chi vi opera; in questa prospettiva si collocano, in particolare, le discipline volte a definire, delineandone una “tassonomia”, le attività economiche ecosostenibili[17] e quelle, in materia di cc.dd. green bonds[18], che mirano a fissare le condizioni alle quali potersi presentare sul mercato utilizzando denominazioni (quelle, a seconda dei casi, di obbligazioni verdi europee ovvero, in termini meno impegnativi, commercializzate come ecosostenibili o semplicemente legate alla sostenibilità) che evocano attenzione ai temi della sostenibilità[19]: la quale, allora, assume, in queste ipotesi, una rilevanza appunto solo strumentale, al pari di quanto è a dirsi, come si vedrà, a proposito della società benefit.
In altri casi ancora, infine, assai più rari, la sostenibilità viene in considerazione come oggetto di tutela in quanto tale, come accade nella recente direttiva in materia di due diligence[20], che prevede, a carico di imprese di ingenti dimensioni, specifici doveri (non già di diligenza, ma) di vigilanza[21]: nel qual caso l’impresa è tenuta non soltanto ad informare il mercato degli impatti negativi che essa è in grado di comportare sulla sostenibilità, ma, ben più incisivamente, ad individuare, prevenire ed arrestare tali impatti; in queste ipotesi, la tutela della sostenibilità prende forma nella previsione, in capo all’impresa, e dunque, nel caso di impresa societaria, agli amministratori, di doveri di comportamento, più o meno intensi e più o meno specifici, ispirati all’esigenza di realizzare obiettivi di sostenibilità sociale o ambientale, che rappresentano altrettanti costi ineludibili per l’impresa, al pari, se si vuole, dell’imposizione fiscale: è anzi proprio a seconda dell’intensità e della specificità di siffatti doveri che si è soliti misurare, e valutare, ma su un piano squisitamente politico, la sensibilità ambientale e sociale delle scelte operate dall’ordinamento.
In questa sede, appare sufficiente osservare come siffatti doveri, di là dal loro contenuto, rappresentano, tecnicamente, e soltanto, altrettanti limiti, legali ed esterni, alla libertà di iniziativa economica: limiti, questi, ovviamente non soltanto del tutto legittimi, ma che, tutte le volte in cui siano diretti ad evitare danni non solo alla libertà e alla dignità umana, ma anche, come (all’esito delle modifiche apportate con l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1) ora dispone il secondo comma dell’art. 41 Cost., alla salute e all’ambiente, valgono ad attuare lo stesso precetto costituzionale[22]; fino a quando si tratti di limiti siffatti alla libertà di iniziativa economica, l’unico problema che si pone è quello della valutazione, politica, e dunque di merito, delle norme che li prevedono: la situazione, invece, finirebbe per modificarsi radicalmente, ove si rinvenisse nel perseguimento di obiettivi di sostenibilità non economica, nella sua accezione sociale o ambientale, un compito che l’impresa è tenuta in quanto tale ad assolvere[23], e cioè l’espressione di una funzione, interna, che essa sarebbe chiamata in quanto tale, e necessariamente, a realizzare[24].
In quest’ultima eventualità, di là dal conflitto, allora da regolare, che finirebbe per emergere rispetto ad altri interessi, a partire da quello dell’imprenditore e dei soci, si assisterebbe, infatti, ad una modificazione della stessa qualificazione dell’iniziativa economica, che da libertà, e cioè attività libera, allora anche nei fini, come il primo comma del citato articolo la definisce, finirebbe, come un tempo da taluno si sosteneva in ordine alla proprietà, per diventare appunto una funzione, cioè una prerogativa riconosciuta dall’ordinamento non già nell’interesse esclusivo del titolare, ma anche, e innanzitutto, nell’interesse altrui: un esito, questo, che, di là, ancora una volta, da ogni valutazione di merito, non pare raggiungibile in via interpretativa, e dunque in definitiva sulla base di preferenze personali dell’interprete, ma renderebbe necessario un intervento, francamente irrealistico, e della cui compatibilità con il diritto europeo appare quantomeno legittimo dubitare, da parte dello stesso legislatore, che determini, con legge[25], gli opportuni programmi e controlli richiesti, dal terzo comma della medesima disposizione, al fine di indirizzare l’iniziativa economica a fini sociali, e ora anche ambientali, purché specificamente indicati[26], con ciò precludendo la possibilità stessa di funzionalizzare l’impresa richiamandosi ad una generica istanza di sostenibilità.
4. Società e scopo di lucro.
Spostando l’attenzione sulla società, intesa come strumento di investimento dei soci, appare opportuno in primo luogo ribadire, che, in generale, gli amministratori, al pari dell’imprenditore, sono tenuti a realizzare esigenze di sostenibilità soltanto in attuazione di (specifici) doveri previsti dalla legge, in assenza dei quali esse risultano recessive rispetto allo scopo di lucro, in senso tanto oggettivo quanto soggettivo, che caratterizza l’attuale disciplina delle società: così, per un verso, gli amministratori, beninteso nel rispetto di siffatti doveri, che rappresentano altrettanti limiti generali all’esercizio dell’attività di impresa, e nell’ambito segnato dall’oggetto sociale prescelto dai soci, sono tenuti a perseguire in via esclusiva l’interesse lucrativo di questi ultimi, in caso contrario potendo essere chiamati a rispondere nei loro confronti, mentre, per altro verso, il lucro così generato è destinato, altrettanto esclusivamente, ai medesimi soci.
Tutto ciò è a dirsi, appunto, in via generale, e dunque indipendentemente, oltre che da ogni considerazione in ordine all’opportunità di modificare la funzione stessa dello strumento societario, dalla previsione di specifiche regole volte ad assegnare rilevanza ad esigenze di sostenibilità, siano esse di fonte legale o statutaria: queste seconde, ovviamente, nei limiti in cui risultino compatibili con le prime e, più in generale, con il sistema[27]; l’esigenza, coerente con la presente occasione, di mantenere il discorso su un piano generale suggerisce di concentrare l’attenzione sulle regole legali, e segnatamente su quelle volte a dettare discipline di portata appunto generale: prescindendo allora sia dall’esame delle clausole statutarie, sia dalle disposizioni, in realtà le più numerose, ed alle quali si è già avuto modo di fare cenno, che risultano destinate ad applicarsi soltanto a talune società, individuate in ragione dei caratteri, dimensionali, delle imprese in cui prendono forma, che la legge mostra allora di considerare in questi termini, in quelli appunto di forma di esercizio dell’impresa.
Si avrà in particolare riguardo a tre diverse figure, quelle dell’impresa sociale svolta in forma societaria, della società benefit e delle società, diverse da queste ultime, con finalità di beneficio comune, e dunque “sostenibili”.
L’impresa sociale (d.lg. 3 luglio 2017, n. 112) si risolve nell’esercizio, da parte di un “ente”, di “attività di interesse generale”, rientranti tra quelle tassativamente indicate dalla legge, e volte al perseguimento di “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, e cioè ascrivibili all’intero ambito della sostenibilità, tanto sociale, quanto ambientale, “adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento” di tutti i portatori di interesse, a partire dai “lavoratori” e dagli “utenti”: essa si caratterizza, in particolare da un lato, per l’assenza di “scopo di lucro” (ferma restando, invece, la necessità dell’adozione di criteri di gestione in grado di assicurarne, programmaticamente, la sostenibilità economica, dal momento che, in caso contrario, non si tratterebbe più di un’impresa); e, dall’altro, per la scelta, diversa da quella operata in ordine agli altri enti del terzo settore (d.lg. 3 luglio 2017, n. 117), che pure possono esercitare (ma non necessariamente esercitano) un’impresa, di consentire espressamente che essa sia svolta anche in una forma, quella societaria, nella quale lo scopo di lucro risulta invece, come detto, essenziale[28]: una scelta, questa, che ha richiesto un duplice adattamento, tanto della disciplina dell’impresa sociale quanto di quella societaria, e cioè un’attenuazione sia dell’incompatibilità tra il perseguimento dello scopo di lucro e la figura dell’impresa sociale, sia della prevalenza dell’interesse lucrativo dei soci che connota le società.
Ne è derivata una disciplina, quella appunto dell’impresa sociale organizzata in forma societaria, che da un lato resta pur sempre caratterizzata dallo scopo di lucro oggettivo: nel senso che l’attività, pur avendo necessariamente ad oggetto un’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e pur dovendo essere svolta secondo le indicate modalità, deve essere comunque diretta a massimizzare la produzione del lucro, beninteso nei limiti concretamente consentiti dal carattere “sociale” dell’impresa; ma che, dall’altro, comprime, senza tuttavia eliminarlo integralmente, lo scopo di lucro soggettivo[29]: attraverso, in particolare, la previsione di limiti quantitativi all’ammontare complessivo di utili in varia forma distribuibili ai soci.
La disciplina delle cc.dd. società benefit (l. 28 dicembre 2015, n. 208, commi 376-384) appare invece volta non tanto e non solo a realizzare esigenze “sostenibili” dei soci, quanto piuttosto, e soprattutto, ad adottare una specifica strategia, o, come pure è stato detto, un peculiare modello di impresa[30], in grado di intercettare le preferenze non economiche diffuse nel mercato: modello che la legge favorisce consentendo, ma solo in presenza di determinati presupposti, di presentarsi sul mercato con la qualificazione di società benefit; la disciplina in esame si risolve appunto nella previsione di una serie di condizioni in presenza delle quali la società è legittimata ad utilizzare, accanto alla denominazione sociale, la dicitura di società benefit: tra le quali particolare rilevanza presenta il perseguimento, attraverso il raggiungimento di specifici obiettivi annualmente indicati dagli amministratori, di attività di beneficio comune, in assenza del quale l’utilizzazione di una dicitura siffatta esporrebbe la società all’applicazione delle sanzioni, pubblicistiche, previste in caso di pubblicità ingannevole e di pratiche commerciali scorrette.
Anche nella società benefit, del resto, l’intero lucro prodotto dall’attività sociale continua ad essere destinato ai soci: attività che, tuttavia, gli amministratori sono tenuti ad esercitare “in modo” non solo “responsabile… e trasparente”, ma, questa volta, anche “sostenibile”, nei confronti di tutti i portatori di interesse, e nel rispetto del dovere, espressamente previsto a pena di responsabilità, di operare un “bilanciamento” tra l’interesse, lucrativo, dei soci e le finalità di beneficio comune, indicate nell’oggetto sociale, senza peraltro pregiudicare l’interesse di coloro sui quali l’attività della società potrebbe finire per incidere.
Siffatto bilanciamento, in particolare, si opera in sede di individuazione degli obiettivi annuali che la società intende raggiungere, che gli amministratori devono selezionare in modo che al perseguimento delle finalità di beneficio comune risultino destinate risorse consistenti, e non irrisorie, ma in misura comunque coerente alla massimizzazione dell’interesse lucrativo dei soci: nel senso che il costo, strutturale, derivante dal raggiungimento di tali obiettivi (che vale a deprimere, dall’esterno, l’utile, come detto destinato esclusivamente ed integralmente ai soci) deve essere comunque inferiore al vantaggio economico atteso dalla possibilità di utilizzare la dicitura di società benefit, e con l’esito che gli amministratori dovranno indicare obiettivi raggiungibili appunto con un impiego di risorse ad esso inferiori.
Ultimo modello di società da prendere in considerazione è quello evocato dalla stessa disciplina della società benefit, nella parte in cui consente di indicare nello statuto finalità di beneficio comune anche a società diverse da quelle benefit, che cioè non ambiscano ad ottenere, e ad utilizzare, la relativa qualificazione (l. n. 208 del 2015, comma 379), con l’unico scopo, questa volta sì, di dare rilevanza statutaria ad interessi non economici dei soci: interessi che costoro intendono tuttavia perseguire avvalendosi di una forma, quella societaria, che, in assenza di espresse disposizioni positive, come detto necessarie al fine di consentire alterazioni del modello ordinario, mantiene intatta la connotazione lucrativa che la caratterizza.
Al fine di rendere tra loro coerenti, o comunque non incompatibili, le finalità di beneficio comune e lo scopo di lucro, in senso tanto oggettivo quanto soggettivo, deve ritenersi che attraverso l’indicazione di tali finalità nello statuto i soci intendano imprimere, stabilmente, al lucro a loro, e solo a loro, anche in tal caso pur sempre spettante, prodotto attraverso lo svolgimento dell’attività economica, la specifica destinazione di finanziare, altrettanto stabilmente, l’attività, non economica, diretta al perseguimento di siffatte finalità: un’attività, quest’ultima, anch’essa, a ben vedere, sociale, in quanto appunto volta a realizzare una finalità prevista nello statuto; è infatti proprio l’inserimento di tali finalità nello statuto, e in particolare nell’oggetto sociale, che impedisce di parlare, in tal caso, di limitazione del lucro soggettivo o comunque di una sua etero-destinazione, in vero contrastante con lo scopo di lucro in senso soggettivo, trattandosi, al contrario, del reinvestimento di utili destinati integralmente ai soci, ma che costoro decidono di impiegare, attraverso la medesima società, al fine di realizzare propri interessi non economici, rinunciando allora non già alla spettanza, ma alla sola percezione delle relative somme in forma di dividendi: una possibilità, questa, offerta ovviamente anche alle società benefit, ma che non rappresenta una condizione per ottenere la relativa qualificazione.
In altri termini, tali società, oltre a quella, consueta, di strumento di investimento dei soci, svolgono altresì la funzione, ulteriore, di forma (almeno) di finanziamento (se non anche di organizzazione) di attività benefiche: il che non soltanto esclude in radice qualunque conflitto tra scopo lucrativo e finalità benefiche, e dunque la necessità stessa di operare un qualche bilanciamento o coordinamento tra siffatte funzioni; ma vale, al contrario, a renderle tra loro complementari: nel senso che l’attività benefica finisce per dipendere integralmente, dal punto di vista finanziario, da quella svolta a scopo di lucro.
Al riguardo, appare opportuno limitarsi ad osservare che se nella figura delle imprese sociali organizzate in forma societaria funzione lucrativa e finalità non economiche sono considerate come tra loro in conflitto, nelle società con finalità benefiche le medesime funzioni si presentano, tutto al contrario, come complementari, per quanto in senso opposto: nella società benefit, infatti, il perseguimento delle finalità di beneficio comune è strumentale alla realizzazione dello scopo di lucro, mentre nelle altre società con finalità benefiche è quest’ultimo a risultare strumentale alle prime.
Al problema del rapporto tra scopo di lucro e sostenibilità la disciplina positiva mostra, insomma, di offrire una pluralità di soluzioni diverse, ciascuna relativa allo specifico modello societario preso in considerazione: soluzioni, queste, che peraltro non esauriscono il novero di quelle astrattamente possibili, che sono a ben vedere infinite, come è a dirsi di ogni equazione a due incognite, compresa allora quella dalla quale si erano prese le mosse.
[*] Il lavoro riproduce il testo della relazione tenuta il 25 ottobre 2024 nell’ambito della Sessione IV – Iniziativa economica privata del convegno di studi dal titolo Dottrine generali della sostenibilità. Verso una teoria del «diritto privato sostenibile»?, organizzato nei giorni 24-26 ottobre a Viterbo, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, sociali e pedagogiche dell’Università degli Studi della Tuscia.
[1] C. Angelici, “Società” in Europa: parole e paradigmi, in Trattato delle società, diretto da V. Donativi, Tomo I, Parte I, Società in generale, Torino, 2022, da 4 (e in Governance e mercati. Studi in onore di Paolo Montalenti, a cura di M. Callegari, S.A. Cerrato, E.R. Desana, Tomo I, Torino, 2022, da 3), 5 ss.
[2] U. Tombari, “Potere” e “interessi” nella grande impresa azionaria, Milano, 2019, A. Genovese, La gestione ecosostenibile dell’impresa azionaria. Fra regole e contesto, Bologna, 2023.
[3] M. Libertini, Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell’impresa, in Riv. soc., 2009, da 1, 26 ss., Id., Sulla nozione di libertà economica, in Contr. e impr., 2019, da 1255, 1269 ss.
[4] E. Barcellona, Shareholderism versus stakeholderism. La società per azioni contemporanea dinanzi al “profitto”, Milano, 2020, 2 ss.
[5] C. Angelici, Note minime sull’“interesse sociale”, in Banca, borsa, tit. di cred., 2014, I, da 255, M.S. Spolidoro, Interesse, funzione e finalità. Per lo scioglimento dell’abbraccio tra interesse sociale e Business Purpose, in Riv. soc., 2022, da 322, U. Tombari, Lo “scopo della società”: significati e problemi di una categoria giuridica, ivi, 2023, da 339.
[6] E. Barcellona, op.cit., 76, testo e nota 53.
[7] C. Angelici, “Potere” e “interessi” nella grande impresa azionaria: a proposito di un recente libro di Umberto Tombari, in Riv. soc., 2020, da 5, 8 ss.
[8] C. Angelici, Divagazioni sulla “responsabilità sociale” d’impresa, in Riv. soc., 2018, da 3, 10 ss.
[9] G. Marasà, L’imprenditore, artt. 2082-2083, in Il Codice Civile. Commentario fondato e già diretto da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli e G. Ponzanelli, Milano, 2021, sub art. 2082, da 3, 20 ss. 132 ss., e già Id., Impresa, scopo di lucro ed economicità, in AGE, 2014, da 33, 35 ss.
[10] G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, XVII Ed., a cura di C. Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2023, 32 s.
[11] M. Stella Richter jr, Long-termism, in Riv. soc., 2021, da 16 (e in Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo, a cura di C. Costa, A. Mirone. R. Pennisi, P.M. Sanfilippo, R. Vigo, Vol. II, Impresa, Società, Crisi d’impresa, Tomo II, Torino, 2021, da 901), 24 ss., E. Ginevra, Il Codice di Corporate Governance: Introduzione e Definizioni (con un approfondimento sul “Successo sostenibile”), in Riv. soc., 2023, da 1017.
[12] G. D’Attorre, La responsabilità sociale dell’impresa insolvente, in Riv. dir. civ., 2021, I, da 60.
[13] M. Maugeri, Informazione non finanziaria e interesse sociale, in Riv. soc., 2019, da 1020, M. Rescigno, Note sulle regole dell’impresa sostenibile. Dall’informazione non finanziaria all’informazione sulla sostenibilità, in AGE, 2022, da 165.
[14] Dir. 2014/95 UE del 22 ottobre 2014 (c.d. NFRD), attuata in Italia con d.lg. 30 dicembre 2016, n. 254.
[15] Dir. 2022/2464 UE del 14 dicembre 2022 (c.d. CSRD), attuata in Italia con d.lg. 6 settembre 2024, n. 125, e Reg. UE 2923/2772 del 31 luglio 2023.
[16] Reg. UE 2019/2088 del 27 novembre 2019 (c.d. SFDR).
[17] Reg. UE 2020/852 del 18 giugno 2020 e Reg. UE 2021/2178 del 6 luglio 2021.
[18] Reg. UE 2023/2631 del 22 novembre 2023.
[19] M. Maugeri, Le obbligazioni “verdi”: problemi e prospettive, in Riv. dir. comm., 2024, I, da 373.
[20] Dir. 2024/1760 UE del 13 giugno 2024 (c.d. CSDDD).
[21] M. Libertini, Sulla proposta di Direttiva UE su “Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese”, in Riv. soc., 2021, da 325.
[22] V. Cariello, Per un diritto costituzionale della sostenibilità (oltre la “sostenibilità ambientale”), in ODCC, 2022, da 413.
[23] F. d’Alessandro, Il mantello di San Martino, la benevolenza del birrario e la Ford Modello T, senza dimenticare Robin Hood (divagazioni semi-serie sulla c.d. responsabilità sociale dell’impresa e dintorni), in Riv. dir. civ., I, 2022, da 410, 440 ss.
[24] B. Libonati, Ordine giuridico e legge economica del mercato, in Riv. soc., 1998, da 1540, ora anche in Id., Scritti giuridici, Vol. I, Milano, 2013, da 615 (dal quale si cita), 631 ss.
[25] G. Ferri, op.cit., 13 s.
[26] G. Minervini, Contro la “funzionalizzazione” dell’impresa privata, in Riv. dir. civ., 1958, I, da 618, in Studi in memoria di Lorenzo Mossa, Vol. III, Padova, 1961, da 21, ora in Id., Scritti giuridici. Impresa e concorrenza, Napoli, s.d., ma 1996, da 57, 59 ss. e 79 s., B. Libonati, op.cit., 633 ss., M. Libertini, Impresa e finalità sociali, cit., 27 ss.
[27] M. Cian, Clausole statutarie per la sostenibilità dell’impresa: spazi, limiti e implicazioni, in Riv. soc., 2021, 475, 485 ss.
[28] G. Marasà, Gli enti del terzo settore: attività e scopi, in Riv. dir. civ., 2023, I, 1169, 1170 ss.
[29] G. Ferri, op.cit., 34 s.
[30] M. Palmieri, Le società benefit, Riv. soc., 2023, da 1030, 1042 ss.